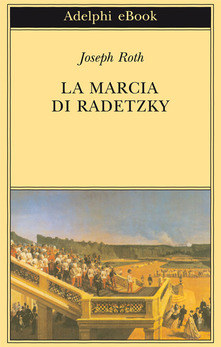
È difficile, di fronte ad un’opera come “La Marcia di Radetzky”, evitare di pensare all’uomo Joseph Roth, prima che allo scrittore: una biografia di sradicato – mi si conceda il termine abusato e poco felice – che pare l’identikit più coerente per colui che, a ragione, è stato considerato il più grande cantore della dissoluzione dell’Impero Austro-Ungarico; o meglio, per parlare forbito, della “finis Austriae”.
Roth, di famiglia ebraica, era nato in Volinia, nella parte orientale della Polonia: la periferia di una Monarchia, che, pur alle soglie del XX secolo, fondava le sue radici nel Sacro Romano Impero e riuniva un fragile mosaico di popoli, lingue, tradizioni diverse, abbracciando l’Ungheria, Serbia, Boemia, Ucraina, Galizia, Moldavia ed oltre. Un mondo al tramonto in cui la vita quotidiana era scandita da riti e convenzioni (la “Marcia di Radetzky” eseguita in ogni dove, caserme, parate, feste popolari) che rimandavano alle glorie di un fulgido passato, incarnato dall’inossidabile Francesco Giuseppe.
E’ in questo contesto, chiaramente contraddittorio, fatto di gerarchie fossili e benevola tolleranza, dove un lento e quasi inconsapevole disfacimento sembra gravare i personaggi, le vicende familiari e sociali, che, per decenni, dal 1859 al 1917, si incrociano i destini della famiglia Trotta, di stirpe slovena e contadina, e dell’Imperatore.
Durante la campagna d’Italia, il luogotenente di fanteria Joseph Trotta, fortunosamente, salva la vita di Francesco Giuseppe: da qui il titolo nobiliare per “l’Eroe di Solferino”, il suo ricordo in libri di testo, celebrativi fino al taroccamento, ma soprattutto l’onere di trasmettere agli eredi lo spirito di eroico servizio proprio del capostipite. Un compito arduo per il figlio dell’Eroe, Franz, che diventerà un solerte viceprefetto in una provincia della Moravia, quintessenza del funzionario integro e fedele, ma soprattutto per il nipote, Carl Joseph, un militare di carriera, irresoluto, incapace di sopportare il confronto con l’ingombrante e mitizzato nonno; un epigono mediocre e discreto di una gloria mai esistita. Il volontario trasferimento di Carl Joseph ai confini dell’impero, dopo la fine di un rapporto clandestino con la signora Slama, non gli causerà che guai, la perdita dei pochi amici fidati e la caduta nel baratro per il vizio del gioco. Ne uscirà solo grazie ai buoni uffici dell’Imperatore, interpellato in extremis dall’anziano padre, poche ore prima del completo tracollo. Per Carl Joseph, appena congedato, il miraggio di un vita normale, non più condizionata dai riti militareschi, durerà un istante: da lì a pochi giorni scoppierà la prima guerra mondiale e dovrà tornare in servizio.
Qui troverà la morte, tra le prime vittime della grande mattanza del secolo. Da lì a poco anche il vecchio Francesco Giuseppe chiuderà la sua esistenza terrena e, come fosse inevitabile, dopo aver atteso nel parco di Schonbrunn la notizia che il suo Imperatore non c’era più, anche Franz, il devoto e lontano suddito, lo seguirà nell’ultimo viaggio. Personaggi descritti con uno sguardo ironico e disincantato, apparentemente contraddittori nel loro vivere in una società che alla superficie, ma solo alla superficie, si mostrava statica e supina alle tradizioni millenarie dell’aquila bicipite.
ntorno a Carl Joseph, come se questo giovane e precocemente invecchiato virgulto di casa Trotta, mite ed imbranato, fosse destinato ad una perenne clandestinità nei rapporti col gentil sesso, si muovono delle figure di donne, stupendamente disinvolte nel loro essere fedifraghe, perfette interpreti di un’ideale di femminilità anch’essa contraddittoria rispetto ad una società bigotta che vedeva nell’Imperatore il difensore della civiltà cristiana, “in un’epoca conformista in politica e spregiudicata nei sentimenti”: la materna signora Slama, moglie di un non si sa quanto inconsapevole maresciallo a servizio di Franz Trotta, l’insaziabile ed ormai matura signora Von Taussig e la cinica signora Knopfmacher, consorte e poi vedova del sensibile dottor Max Demant , morto in un duello suicida, rassegnato come fosse un’inevitabile e dovuta ribellione a quella vita cui si era condannato; tutto per difendere l’onore di se stesso, dell’amico Carl e forse anche di una donna che non lo meritava.
Roth si dimostra nuovamente quell’abile indagatore dell’animo umano che avevamo conosciuto in romanzi come La tela del ragno, Hotel Savoy, Giobbe: paradigmatico il complesso rapporto padre-figlio, pieno di sfumature e di parole non dette tra due timidi palesemente condizionati dall’ombra dell’Eroe e da tutti i doveri cui ne derivavano; ma ne “La Marcia di Radetzky” è tutta la fauna umana, che appare ben delineata nei sentimenti di paura, debolezza, sacrificio,orgoglio, onore, tradimento, onestà; a cominciare da Francesco Giuseppe, anche lui giunto al termine della vita ed ormai insofferente alle convenzioni ed alle opprimenti premure riservategli da quei servitori che, a lui anziano e malato, gli precluderebbero anche la contemplazione della natura.
Era proprio lui, l’Imperatore, la devota ubbidienza e l’incondizionata fiducia alla sua persona, che nei secoli erano stati il collante per unire in una civile convivenza delle culture altrimenti estremamente diverse e forse incompatibili; solo pensare che una rinnovata nostalgia per le glorie asburgiche potesse arginare le sempre più potenti istanze irredentistiche e nazionalistiche appariva un mera illusione: il giorno dell’assassinio del principe Francesco Ferdinando, nella guarnigione di confine dove il nipote dell’Eroe si è volontariamente segregato, quegli ufficiali che, pur lontani da Vienna, parevano vivere da sempre in perfetta sintonia con le tradizioni, non nascondono più la loro gioia.
La monarchia ormai era incapace di tenere a freno le aspirazioni nazionali e si mostrava sempre più come un potere destinato ad un rapido declino. Una vicenda che raccontata così, con questa sequenza di morti e di sfacelo potrebbe apparire d’una tragicità senza fine; in realtà l’affresco storico di Roth, proprio di un’epica che vive più di vicende umane piuttosto che di potere ed ideologie, si rivela caratterizzato da umana comprensione, dalla rievocazione di mondo che conosceva bene, con uno sguardo disincantato ed anche ironico, privo di autentico cinismo. In Roth un sentimento nostalgia, al tramonto di un’epoca, prevale su di una sostanza che, anche nel romanzo, non fa velo ad autentiche ed ineluttabili tragedie umane.
“Avrei anche accennato volentieri” disse il borgomastro, “che il signor Trotta non poteva sopravvivere all’imperatore. Non lo crede lei, signor dottore?”.
“Non lo so” rispose il dottor Skowroneck, “io credo che nessuno dei due potesse sopravvivere all’Austria”.
Con la fine della monarchia austro-ungarica era scomparso quell’equilibrio e quella tolleranza che avevano dato una patria anche all’ebreo Joseph Roth. Da allora lo scrittore vivrà il difficile passaggio alla repubblica di Weimar e poi dal 1933, per fuggire dal neonato regime nazista, si vedrà esule a Parigi: la biografia, il cui epilogo da lì a poco sarà ben più drammatico, spiega bene questo suo rimpianto per il passato e la nostalgia per quegli ultimi anni di un’Austria patriarcale e centenaria che pareva non dover finire mai.
Edizione esaminata e brevi note
Edizione esaminata: Adelphi, 1996
– Recensione già pubblicata su ciao.it l’11maggio 2006-





Follow Us