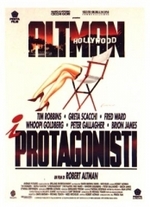
Robert Altman, divenuto regista di fama internazionale con pellicole come M.A.S.H. (1970) e Nashville (1975), vide il suo cinema, comunque originale, trovare una serie di insuccessi lungo l’arco degli anni Ottanta, cui seguì un periodo di sostanziale silenzio artistico per lo più dovuto alla difficoltà di reperire produttori che ancora credessero nella sua arte. Nonostante queste difficoltà, e grazie al credito artistico maturato negli anni, all’inizio degli anni Novanta partorì un’opera di notevole spessore cui gratuitamente parteciparono – impersonando se stesse – molte star hollywoodiane. Una pellicola che stigmatizza, sotto forma di satira corrosiva, vezzi, giochi di potere e assurdità assortite del cinico mondo degli studios hollywoodiani. Un folto gruppo di avvoltoi senza scrupoli, più spesso carnefici e qualche volta vittime di un sistema di potere che non ha eguali nel variegato mondo della settima arte, sono I protagonisti della pellicola di Altman: produttori, sceneggiatori, registi, attori, tutti accomunati dalla smania di successo e di potere, dal delirio d’onnipotenza che genera forme di prevaricazione che culminano con l’annientamento di chi intralcia i loro piani.
Griffin Mill (Tim Robbins), potente boss di Hollywood ai vertici di una nota casa di produzione cinematografica, è colui che decide le sorti degli scrittori per il cinema, dovendo scegliere un massimo di dodici soggetti l’anno tra le migliaia che gli vengono proposti. È cinico e arrogante quanto basta per far annegare in lacrime e disperazione i sogni e le aspirazioni dei tanti che cercano un’opportunità per sfondare. Appare chiaro che, operando in questo modo, qualche nemico ce lo si può anche esser fatto e che l’invidia di colleghi e sottoposti è una routine con cui dover convivere. L’invidia dei colleghi può anche gratificare, ma le minacce anonime – ricevute per cartolina – molto meno. Mill comincia cosi ad indagare, spulciando tra la miriade di sceneggiatori cui aveva sbattuto la porta in faccia, nel tentativo di scovare il responsabile delle minacce. Dopo una breve ricerca, è persuaso che il persecutore sia un giovane scrittore privo di talento. Prova quindi a contattarlo telefonicamente, ma dall’altro lato della cornetta risponde la fidanzata (Greta Scacchi), con la quale il produttore si intrattiene per capire dove sia il ragazzo. Scopre che è in un cinema d’essai dove proiettano Ladri di biciclette, lo raggiunge, si intrattiene con lui in un bar e gli promette una scrittura, convinto cosi di poter risolvere il problema. Ma lo sceneggiatore è orgoglioso, non accetta, si dice estraneo all’invio di lettere minatorie, infastidito non poco dalle accuse ricevute. Ma Mill insiste, lo segue fino alla macchina, dando involontariamente luogo ad una colluttazione in cui il giovane trova la morte. Nessun testimone, pertanto nessun rimorso. Mill occulta le poche tracce lasciate e si avvia verso casa convinto di aver risolto la questione delle minacce. Così non è, perché il persecutore non è il ragazzo deceduto ma qualcuno che si nasconde bene nell’ombra. La polizia indaga e risale fino al produttore che, nel frattempo, si trova a combattere una battaglia interna agli studios contro un giovane rampante che è pronto a fargli le scarpe. Non solo, Mill intreccia una relazione con la fidanzata dello sceneggiatore deceduto, in un primo tempo ignara del tragico accaduto. Nonostante le pressioni della polizia, le lettere anonime che non si arrestano, le lotte interne alla casa di produzione, il cinico manager d’industria trova il modo di eludere ogni difficoltà, riuscendo a portare avanti la relazione appena instaurata e trovando, infine, il modo di far fruttare la sua disavventura.

Un grande Altman, cinico e spietato fustigatore del malcostume e delle contraddizioni d’America, costruisce quella che, a mio parere, è la sua migliore pellicola in assoluto. Nessuno, prima di questo film, se si eccettua l’immortale capolavoro Viale del tramonto, era mai riuscito a mettere a nudo cosi bene l’orrore che si nasconde dietro l’industria hollywoodiana, quel mondo luccicante che evoca sogni che si trasformano facilmente in incubi. È logico credere, visto che si sono prestate note star del settore, che quella altmaniana non sia affatto una caricatura della realtà ma solo una cruda semplificazione che lascia presagire un livello di marciume umano ancor peggiore di quello che viene rappresentato.
Il regista americano si muove con l’ausilio di una sceneggiatura che mescola mistero e commedia nera, scegliendo un andamento circolare per dare compiutezza alla storia narrata. Un piano sequenza lunghissimo (otto minuti, degno del Welles d’annata) apre la pellicola, attraverso il quale l’occhio di Altman sbircia tra le nevrosi ossessive di uno mondo – quello degli studios – che sembra sempre parlarsi addosso pur quando evoca capolavori della settima arte, beffardamente analizzati in un ambito di costi e ricavi. Alt. Prevengo una possibile critica: no, non siamo verginelle sperdute lungo il sentiero, sappiamo bene – e meglio di noi Altman – che Hollywood è un’industria e che come tale si misura sui profitti. Ma sappiamo altrettanto che è, o dovrebbe essere, una fabbrica di sogni come qualsiasi altro settore impegnato a costruire arte da diffondere nel mondo.

Ciò che vediamo, ci insegna Altman attraverso la pellicola, è un prodotto finito, pensato sempre con un lieto fine. Ma dietro quel prodotto c’è sempre anima, sangue, sudore, sogni, spesso frustrati da chi ha il potere di vita o di morte su una pellicola. Ecco che, nel caustico epilogo, i due sceneggiatori che tanto agognavano un contratto per vedere trasposta senza alterazioni la propria creatura, si piegano senza batter ciglio al finale scelto dal produttore – quasi felici della correzione apportata in corsa. Ancor più felici dei soldi ricevuti.
Robert Altman, da poco deceduto, non pare volerci fare la morale, sembra invece voler ricordare che l’arte è soprattutto indipendenza e salvaguardia del sogno originario, una via di libertà per evadere dalla consuetudine e dai meccanismi del potere. Hollywood non l’ha mai amato, come non hai mai amato David Lynch, Woody Allen e tanti altri grandi registi che noi tutti amiamo. Il motivo di questo “non amore”, ripercorrendo la carriera del Nostro, è semplice ed evidente: disprezzo delle logiche dello star system. I protagonisti, nonostante – o forse proprio per – la partecipazione amichevole di personaggi come Susan Sarandon, Julia Roberts, Burt Reynolds, Rod Steiger, Peter Falk, Jeff Goldblum, Bruce Willis, Nick Nolte, John Cusack, Malcom McDowell, James Coburn (e tanti altri, un numero davvero impressionante di volti noti), confermò Altman come uno dei più strenui oppositori di Hollywood. Per certi versi questo memorabile apologo altmaniano è una pellicola agghiacciante che non fa affatto sorridere, che confonde volutamente realtà e finzione lasciando un retrogusto amaro nella bocca dello spettatore. Per gli amanti del cinema, non solo di Altman, assolutamente da non perdere.
Federico Magi, novembre 2006.
Edizione esaminata e brevi note
Regia: Robert Altman. Soggetto e sceneggiatura: Michael Tolkin. Direttore della fotografia: Jean Lépine. Montaggio: Maysie Hoy, Geraldine Peroni. Scenografia: Stephen Altman. Costumi: Alexander Julian. Interpreti principali: Tim Robbins, Greta Scacchi, Fred Ward, Whoopi Goldberg, Peter Gallagher, Brion James, Cynthia Stevenson, Vincent D’Onofrio, Dean Stockwell, Richard E. Grant, Sidney Pollack. Musica originale: Thomas Newman. Titolo originale: “The Player”. Origine: Usa, 1992. Durata: 124 minuti.





Follow Us