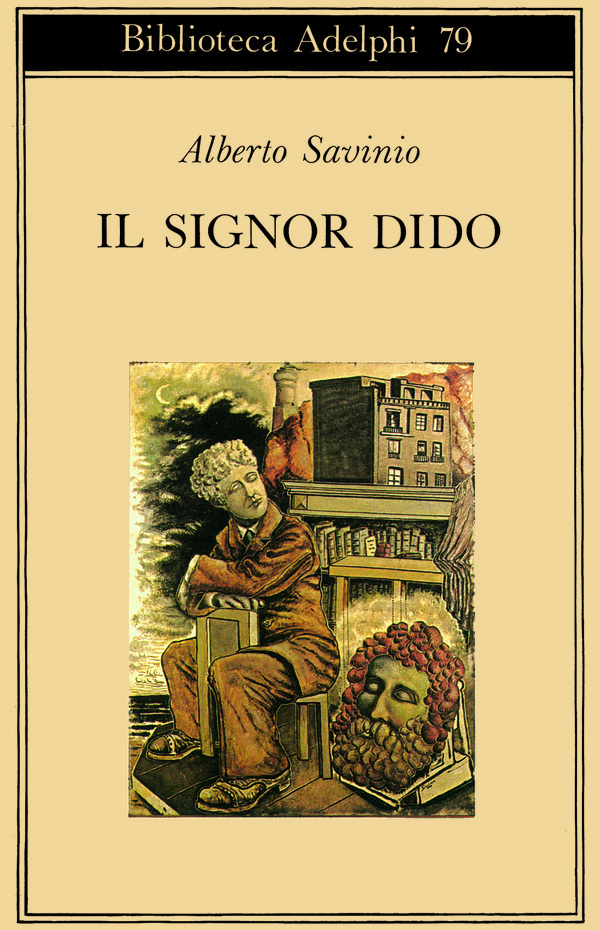
In barba a chi crede nel tema del doppio nella sua letteratura, Savinio crea un personaggio, il signor Dido, che è uno e trino. L’ego, in realtà, si moltiplica di continuo lungo il racconto, nascosto fra le righe o quando parla, in prima e terza persona. C’è l’io che rincorre i suoi pensieri; il signor Dido e la sua famiglia, e la casa, e lo studio; c’è il signor Dodi e il suo spiacevole incontro.
La scrittura di Savinio è di una intelligenza che ferisce. Viene da immaginarselo, questo sessantenne sornione, taciturno e distratto, che invece tutto vede e poi riferisce. Una spia votata alla sua lingua biforcuta, che rammenda la realtà col mito, e da questo risale al presente, in uno scontrarsi di tempo infinito e quotidianità che genera il sogno e la sua percezione atemporale. L’arma vincente è un’ironia affilata che talvolta genera immagini comiche di altissima levatura e immediatezza – talune sono percepibili da autentici dadaisti nell’animo. Frasi come questa sono capaci di condurre alle lacrime e a feroci spasmi:
“Stasera non si mangia” disse la signora seduta sul tamburo. “Avevo messo due pizze al forno. Ma Tullio ha sonato Musica delle sfere, e le pizze han fatto acquetta”.
Che cosa ella intendesse col dire che le pizze per l’insonora musica di suo marito avevano fatto acquetta, il signor Dido non riuscì a saperlo” (pag. 769)
Fulmineo, teatrale, eccezionale. Il signor Dido è un romanzo breve – centocinquanta pagine o giù di lì – e ruota attorno all’egocentrismo di un egocentrico. I confini del suo mondo corrispondono alla punta delle sue scarpe, o ai rumori fuori la finestra, dove frammenti di romanesco dei ragazzini per le strade, gli disturbano la concentrazione. Anche l’uomo-candela disturba l’io innominato: il tale è un certo Katz che l’autore non chiama per intero poiché “in italiano suona con significato indecente” (pag. 692). Fra i disturbatori e i comprimari, si delineano le sembianze del protagonista: vive a Roma, con la moglie e i suoi figli; è pittore, musico e scrittore. Però, il signor Dido, è calvo. Gli altri? Non importa. L’io che parla in prima persona è un paterfamilias frustrato; non sopporta di essere un emarginato, non tollera che sia additato come un diverso, come il capo e quindi colui che non è allo stesso livello dei suoi subalterni. Egli è nemico, questo sì, dei suoi figli. Naturale. E quest’odio sboccia durante il rito del desco. Qui Savinio sfiora le corde più indovinate di tutto il testo e, nel suo delirare comico, descrive un quadro estremamente realistico: la rivalità fra genitori e figli durante il pranzo. Chi ha convissuto in una famiglia cosiddetta ‘normale’, non è estraneo a quanto segue:
“Ci sediamo a tavola per mangiare: io, mia moglie, mia figlia, mio figlio. Io domani compio cinquantotto anni, mia moglie il cinque settembre prossimo ne compirà cinquanta, mia figlia Angelica alla fine di questo mese ne compirà ventuno, mio figlio Ruggero il ventidue del prossimo dicembre ne compirà quindici. E ci sediamo a tavola per mangiare assieme. Gli stessi cibi… Assurdo!” (pag. 716)
Già per questo il lettore si elettrizza. Pensa ai suoi pranzi, ai risucchi, ai falsi complimenti. Savinio va oltre:
“Ma antipatia fra padri e figli c’è. C’è anche odio. Tanta più antipatia, tanto più odio, in quanto le condizioni di antipatia e di odio sono molto più frequenti fra coloro che si amano, e sono uniti nonché dall’amore ma da vita comune, da mezzi comuni, da affetto comune per uomini e cose, da abitudini comuni. Antipatia e odio non escludono simpatia e amore, così come simpatia e amore non escludono antipatia e odio. Anzi. Convivenza strana, ma convivenza” (714).
Il signor Dido la prende con più allegria: “Odiare vuol dire aver tempo da perdere” (pag. 778). Nella ricerca di sé nel rifugio casalingo, il signor Dido vaga di stanza in stanza. Trova dapprima il figlio con i suoi amici e bofonchia: “Trappola”. Poi trova la cameriera che rassetta: “Trappola”. Per sfuggire alla trappola della responsabilità finisce nel bagno dove è impossibilitato a far pipì per via della cagnetta che, in quanto signorina, non potrebbe stargli davanti mentre lui fa certe cose. Nel suo studio, in cui sembra non riuscire più a produrre, campeggia un nuovo quadro. Sotto il divano, noccioli di olive che mangia di nascosto dalla moglie. Cerca di concentrarsi e non pensare al passato, perché i ricordi “si portano appresso vergogna e rimorso”. Eppure questi si materializzano davanti ai suoi occhi, nel sogno e nella veglia. Il volto di un amore scomparso tragicamente, un soldato tedesco reincarnato in un albero che gli restituisce un suo dipinto rubato nel ’45. Suo nonno morto, l’uomo barbuto, compare di soprassalto durante un pranzo, in un’immagine davvero agghiacciante.
Savinio, il signor Dido e il signor Dodi hanno in comune un episodio, una visita inaspettata in una villa. La scena si ripete distorta e differente per ognuno di loro, chi incontra un dottore, chi un braccio d’un mostro sprofondato in una poltrona. Creature metafisiche si alternano a figure mitologiche, che esautorano i volti contemporanei, spodestando infine lo stesso Dido, che finisce per trasformarsi in Empedocle, e trovare nelle fiamme dell’Etna la pace e l’eternità.
L’autore vorrebbe si parlasse di sé, a tavola. Descrive i difetti di chiunque incontri, li ridicolizza con un vocabolario straordinario. La sua lingua letteraria è frastagliata, frammentata da una punteggiatura che rallenta i tempi, alla ricerca forse di un tempo lontano, naturalmente mitico e pertanto impercettibile. Un orologio compare, ma è anch’esso ricordo della gioventù, di quel periodo parigino, degli incontri micidiali, della madre, del treno. Il treno è per Savinio corridoio mortale, barca di Caronte che conduce l’anziano (nemmeno sessantenne in realtà) protagonista verso la fine dei suoi giorni.
Perché non c’è altra scelta, vuol vivere il presente, ma in questo presente si scontra con ragazzini che riconoscono la cilindrata di motore a distanze incredibili, con mogli che non capiscono l’arte astratta ma hanno voglia di parlarne, con fantasmi che lo accompagnano man mano verso la consapevolezza della fine.
Il signor Dido è un testo funereo, testamentario, che ci rivela perché i figli beneducati parlano basso (“per non farsi capire dai loro genitori”, 752); dove l’adulto è un bambino che ha già terminato la propria vita e il suo unico compito è quello di lasciar libero il posto. Con un pizzico di cinismo lo si può interpretare come la follia di un artista allucinato che interpreta la vita come i suoi quadri e i suoi romanzi, che comprende la fisica servendosi solo di metafisica e filosofia: non scinde i due mondi, purtroppo, e ne resta poeticamente impigliato.
Il signor Dido è un appartamento che prende vita, è un lungo carrello cinematografico, condito di falshback onirici, che conduce un io frantumato verso il cratere mortale che congiunge la vita terrestre con l’infinito, donandogli finalmente una maschera unica, classica, che gli renda finalmente giustizia in un mondo a volte distratto e spesso poco intelligente.
Edizione esaminata e brevi note
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Alberto Savinio, pseudonimo di Andrea Francesco Alberto de Chirico (Atene 25 agosto 1891 – Roma 5 maggio 1952), scrittore, pittore, saggista, critico, musicista, compositore italiano.
Alberto Savinio “Il signor Dido”, in “Opere. Hermaphrodito e altri romanzi. Vol.1”, Adelphi, Milano, 1995, pp 689-839 a cura di Alessandro Tinterri. Introduzione di Alfredo Giuliani.
Approfondimento in rete: Wiki it





Follow Us