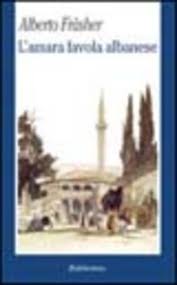
La lettura del libro di Alberto Fràsher, “L’amara favola albanese”, non lascia molti dubbi: è un’opera credibile, che racconta una realtà spaventosa e poco conosciuta. Rimane inevaso soltanto un interrogativo, quello che mi fa preferire di chiamarla “opera” e non in altro modo. In quarta di copertina leggiamo: “il libro, pur non essendo autobiografico, descrive eventi reali e trasformazioni degradanti di una società inizialmente serena e tranquilla”. Nel sito della Rubbettino invece: “Il libro, autobiografico, descrive la metamorfosi di una nazione che nell’arco di quarant’anni si è vista perdere parte della sua identità, fatta di storia, religione e libertà. Le trasformazioni economiche assurde che investono il paese non potevano non incidere sul costume, sul grado di libertà e sulla mentalità di una nazione fragile che, a due passi dal mondo occidentale, aveva smesso di sognare un futuro”. E comunque opera che viene catalogata come “romanzo”, e così definito nella pagina web dell’autore. Al di là delle precise definizioni è plausibile che la storia raccontata da Fràsher sia realmente autobiografica, o quanto meno costruita sulla base di avvenimenti realmente accaduti, non fosse altro per esser stata pubblicata nella collana curata da Dario Antiseri, con il contributo del Centro di Metodologia delle Scienze Sociali della Luiss “Guido Carli” di Roma. Una testimonianza resa con una costruzione appunto in forma di romanzo, e parimenti un documento importante, che testimonia la vita complicata degli italo-albanesi, i “peppini”, per oltre quarant’anni prigionieri in casa loro. Queste le premesse: alla fine della Seconda Guerra Mondiale un accordo del marzo 1945, tra i governi italiano e di Albania, rese praticamente impossibile il rimpatrio delle famiglie italiane di tecnici ed ex-militari residenti sul suolo albanese. La famiglia di Alberto Fràsher, nato proprio nel 1945, era tra queste. Fràsher, rimpatriato in Italia negli anni ’90, dopo aver vissuto infanzia adolescenza e maturità sotto il pesante giogo del totalitarismo comunista, con questo libro ha descritto la vita di un giovane italo albanese, dall’infanzia fino alle soglie dell’Università, in un paese che assicurava gli studi soltanto ai rampolli delle famiglie prive di elementi “controrivoluzionari”. Coloro che invece avessero avuto qualche parente incriminato per tradimento e fucilato (e lì bastava dichiararsi poco entusiasti di come andavano le cose per venire processati) rischiavano la deportazione con tutta la famiglia e l’esclusione dal lavoro e dalle scuole: “un processo durato poco più di un’ora, e la condanna a sedici anni per aver tentato la fuga” (pag. 151)
Un’Albania che di anno in anno appariva sempre più plumbea, oppressiva, dove appunto una sola parola poco ottimista sul futuro del verbo comunista poteva costare anni di galera e la fucilazione. Ma anche un paese che da povero e dignitoso, di anno in anno, diventava sempre più misero; e nel quale gli unici a vivere con agiatezza erano i papaveri del partito unico. Enver Hoxha non viene mai nominato, se non come “leader”, ed anche la presenza del comunismo risulta talmente pervasiva da apparire scontata in un Albania alle prese con le miserie della vita quotidiana; e nella quale tutte le vicende internazionali, i tanti passaggi di campo dal filo-stalinismo al filo-maoismo imbastiti dalla dirigenza del partito, le purghe, le fucilazioni di massa, appaiono sullo sfondo, subiti da una popolazione rassegnata, stordita dalla propaganda e dal fanatismo, e che soprattutto non capisce realmente cosa succeda.
Frasher racconta quando l’Albania divenne il primo stato del Mondo a dichiararsi ufficialmente ateo, con tutto quello che ne è conseguito: “Nelle scuole, nelle fabbriche e in campagna la gente dichiarava la solidarietà alla guerra finale contro la religione. E non solo. Si doveva partecipare alle incursioni che la Gioventù Comunista organizzava nei monasteri e nelle chiese della campagna, nelle moschee e nei cimiteri per portare via croci e altri simboli della credenza popolare. Il grande Movimento Rivoluzionario faceva eco alla rivoluzione culturale del Lontano Oriente. I repertori dei teatri e dell’Opera Nazionale vennero ripuliti da opere del mondo borghese. Traviata e sinfonie di Beethoven furono dichiarate opere eretiche, che non corrispondevano allo spirito del socialismo, alla libertà degli oppressi [….] Nelle strade, la folla, piccone e bandiere tra le mani, correva verso le piazze deserte di chiese e moschee, rovinando tutto: affreschi antici e medievali, altari e icone di santi cristiani e ortodossi”. Poi: “Un paio di anni più tardi seppi che Pirro era stato licenziato e mandato a lavorare in una cooperativa agricola nel sud del paese. Vi ha lavorato per diciotto anni, zappando la terra dalla mattina alla sera. Gli avevano trovato la Bibbia dentro la borsa e i colleghi lo denunciarono” (pag. 222). Qualcosa insomma che fa pensare alla più recente furia talebana: là fanatici religiosi, qui fanatici atei ma stessi risultati. E poi il tempo dei dazebao: “bastava la denuncia pubblica, per il resto ci pensava il Partito”. Un’Albania che di anno in anno ha vissuto una sempre più marcata collettivizzazione e pianificazione dei fattori produttivi, secondo un’interpretazione rigida della dottrina marxista, o quanto meno interpretata all’albanese e dove – la cosa ricorda molto i maiali della Fattoria degli Animali – gli unici a risultare immuni dalla miseria indotta dagli effetti della collettivizzazione forzata erano gli alti dirigenti del partito, confinati nel loro quartiere di lusso.
La storia di Fràsher, come anticipato, per lo più investe gli anni della sua giovinezza, alle prese con le fatiche quotidiane proprie di un paese in miseria, con infrastrutture allo sfascio, la fame, ambienti sporchi, polverosi, pochi libri, il culto della personalità del “leader”, tanta monotonia, un’uniformità imposta di idee, dove ogni trasgressione rispetto la linea dettata dal partito unico significava rischiare la propria vita e rovinare quella dei propri familiari, sia della generazione attuale che di quella futura. Alla fine del racconto, dopo un salto temporale di almeno venti anni, il paradosso del rimpatrio per quegli italiani residenti in Albania, spesso disprezzati e derisi (“peppini”), e che ora in Italia si ritrovavano stranieri a casa loro: “Per quarant’anni oltremare mi hanno considerato un’italianka, adesso mi vengono a dire che siamo degli albanesi. Sono matti o mi prendono in giro?” (pag. 228). Il romanzo, biografia o come vogliate chiamarla, malgrado sia scritto con correttezza formale e con uno stile quasi dimesso che ben si adatta all’argomento, al di là delle considerazioni letterarie, va considerato semmai per quello che è: un documento importante che racconta la vita quotidiana di un paese che era già povero e che la follia di un totalitarismo ha trasformato in poverissimo e misero.
“Per sopravvivere, loro hanno bisogno di sottrarre ogni tanto parte delle nostre libertà, altrimenti addio al potere” (pag. 120).
Edizione esaminata e brevi note
Alberto Fràsher (Tirana, 1945), nato in Albania da madre italiana e da padre cittadino italiano di origine albanese, è stato rimpatriato in Italia (Terni) nel 1990. Laureato in matematica, ha poi conseguito col massimo dei voti il grado di dottore di ricerca presso la cattedra di analisi e topologia del Dipartimento di Matematica dell’Università di Tirana. Nell’ambito dei suoi studi ha pubblicato in Albania e all’estero numerosi articoli sui problemi inerenti la didattica della matematica, nonché una ventina di libri sui nuovi contenuti e le nuove metodologie dell’insegnamento. Una volta giunto in Italia è stato relatore in molte conferenze e convegni sul degrado dei sistemi totalitari nei paesi dell’Est, sui problemi dell’integrazione interculturale.
Alberto Fràsher, “L’amara favola albanese”, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2000.
Luca Menichetti. Lankelot, agosto 2012
Recensione già pubblicata il 18 agosto 2012 su ciao.it e qui parzialmente modificata.





Follow Us