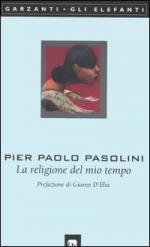
Inizia con una figura d’operaio umile, timoroso sullo sfondo degli affreschi del ciclo “La leggenda della croce” nella chiesa di san Francesco ad Arezzo, la seconda raccolta poetica di Pier Paolo Pasolini dopo il trasferimento a Roma, che raccoglie testi scritti tra il 1955 e il 1960.
È un testo composito, formato da sezioni assai diverse nel contenuto e nella forma, che anch’essa riflette l’evolversi del pensiero dell’autore in questo periodo.
La prima, ampia sezione comprende il lungo poemetto “La ricchezza”, a sua volta articolato in sei capitoli titolati, l’ode “A un ragazzo”, dedicata al giovane Bernardo Bertolucci, figlio d’Attilio, amico di Pasolini e il poemetto eponimo “La religione del mio tempo”.
Dagli affreschi aretini e dall’operaio “col suo minuto cranio” e le “rase mascelle” con un procedimento cinematografico e la consueta sensibilità pittorica lo sguardo del poeta si sposta sui visitatori e poi sugli affreschi e sulla luce “fiati di fiamma dalla vetrata a ponente tingono la parete” (p. 11).
La metrica dipana strofe libere in versi sciolti da obbligo di rima e misura (ma la rima ritorna seppure non con regolarità) e continuamente dilatati dagli incalzanti enjambements.
Osserva D’Elia nella sua introduzione al testo: “Si potrebbe dire, rischiando la banalità, che la costruzione de La ricchezza ricalchi un’impostazione filmica del discorso vissuto, cui presiede la regola del viaggio e del montaggio, della carrellata e della soggettiva; insomma una struttura itinerante e deambulatoria che si dichiara come fondante tutti i poemetti di Pasolini, dove il passo, il viaggio, l’andatura rispondono alla funzione argomentativa, che illustra e riflette accompagnando lo sguardo” (p. VIII).
Da Arezzo lo sguardo dell’io si sposta verso il paesaggio toscano, poi umbro e infine a Roma: sono gli anni di ulteriore scoperta dell’Urbe, dal “cuore campestre dell’Italia” l’Autore va verso il sottoproletariato urbano.
L’io rivendica qui una centralità fortissima: è l’io, il corpo vivo, che si sposta (in autobus, in treno, in auto), che vede, descrive, ascolta, è l’io che riflette su di sé e sulla propria natura, sulla propria diversità, sul proprio essere intellettuale borghese, seppur mescolato ai lavoratori più umili la mattina all’ora di andare al lavoro. Ed è un “io che brucia” di un amore carnale, appassionato per la vita che vede attorno a sé, è la passione già presente nelle “Ceneri” che qui continua ad operare. Pasolini ricorda gli anni della povertà, le periferie, figure di operai, ladri, disoccupati, prostitute sullo sfondo di “lotti tutti uguali, assorbiti dal sole troppo caldo, tra cave abbandonate, rotti argini, tuguri, fabbrichette…” (p. 23).
L’intellettuale borghese, che è stato povero per caso, è in realtà ricco, possiede gli strumenti del sapere, conosce l’arte, gode del privilegio del pensare. Il poeta si definisce: “Poeta, è vero, ma intanto eccomi su questo treno carico tristemente di impiegati, come per scherzo, bianco di stanchezza, eccomi a sudare il mio stipendio, dignità della mia falsa giovinezza, miseria da cui con interna umiltà e ostentata asprezza mi difendo…” (p. 26).
Va “cercando infinite lezioni a un solo verso…” mentre versi evocativi di un lirismo struggente e d’intensità pittorica delineano i paesaggi, la luce (“sfuriate di sole”), in visioni di un realismo quasi allucinato, che tocca uno dei suoi vertici nella “Riapparizione poetica di Roma”.
Il tramonto è “contemplato come in una tarda allucinazione barocca e teatrale, in figura contrastiva incendio-mare, con l’ossimoro in terza rima cielo/sfacelo, a suggerire il grande sfondo della compresenza di tempi e paesaggi, di coste e di secoli, nella raffigurazione più alta che Pasolini abbia dato del fantasma romano, con quell’attacco caldo e tramortito che fa di «Dio» un’interiezione” (p. X).
L’ossimoro è diventato ormai istituzionale nella poesia pasoliniana.
L’io che si muove e ritorna negli stessi luoghi (Ponte Garibaldi) prosegue le sue peregrinazioni attraverso la città nella quarta sezione.
Nel primo dopocena, quando tutti rincasano e gli odori delle cucine si diffondono nell’aria, si muove il poeta – “Ah, essere diverso-in un mondo che pure è in colpa-significa non essere innocente…” (p. 35).
Ed è Roma ancora in tutta la sua bellezza e miseria, Roma amata nella sua impurità, nel suo popolo, nei suoi emarginati, “vecchi ubriachi”, “antiche prostitute”, “frotte di sbandata ragazzaglia”.
Quasi una migrazione nel ripetersi dell’incipit “Vanno verso le terme di Caracalla”: ragazzi in moto “con maschile pudore e maschile impudicizia, nelle pieghe calde dei calzoni nascondendo indifferenti, o scoprendo, il segreto delle loro erezioni…” (p. 37), il pastorello undicenne, il vecchio disoccupato roso dall’alcool. C’è una coralità di personaggi sottoproletari che popola queste liriche.
“Ma nei rifiuti del mondo, nasce un nuovo mondo: nascono leggi nuove dove non c’è più legge; nasce un nuovo onore dove onore è il disonore…” (p. 39)
Speranza ancora in quest’umanità disordinata, povera, sfruttata, abbruttita da vizi e miserie. Verso le terme di Caracalla va anche il poeta col suo privilegio di pensare, “solo fino all’osso” col suo sogno di casa e normalità, mentre lo scenario si popola di prostitute, clienti e magnaccia.
Questo viaggio, questo peregrinare dell’io si snoda in una ricerca che sembra non aver mai fine tra vicoli, casupole, scenari desolati, muretti, androni e figure umane, ragazzi con “canottiere e magliette svolazzanti sopra le vite strette e discinte”, uomini che egli sente “quasi fratelli” seppure con storie tanto diverse dalla sua. Comune è il desiderio di ricchezza: avido, sordido, impudico: “Il loro desiderio di ricchezza è, così, banditesco, aristocratico. Simile al mio. Ognuno pensa a sé, a vincere l’angosciosa scommessa, a dirsi: «È fatta», con un ghigno da re… La nostra speranza è ugualmente ossessa: estetizzante, in me, in essi anarchica” (p. 50).
Entrambi, poeta e popolo, sono fuori dalla storia, presi dal loro bisogno immediato, mossi da una vitalità primordiale, in fondo inconsapevoli – o incuranti – del loro essere storia, occupati dal desiderio contingente.
L’itinerario culmina – in un movimento che dallo spazio chiuso degli affreschi ha condotto verso lo spazio aperto – con una proiezione sotto le stelle di “Roma città aperta” di Rossellini.
L’età della giovinezza friulana e della Resistenza vengono rievocate da Pasolini. Il fratello Guido, ancora una volta è presente. Fu una fase quella di “pura luce”.
“Quella luce era speranza di giustizia: non sapevo quale: la Giustizia. La luce è sempre uguale ad altra luce. Poi variò: da luce diventò incerta alba, un’alba che cresceva, si allargava sopra i campi friulani, sulla rogge. Illuminava i braccianti che lottavano. Così l’alba nascente fu una luce fuori dall’eternità dello stile… Nella storia la giustizia fu coscienza d’una umana divisione di ricchezza, e la speranza ebbe nuova luce” (pp. 58-59).
Ma alle speranze epiche del Dopoguerra – e qui la reazione dell’io, il suo pianto “precedente quasi al dolore” accompagna le sequenze del film – non è seguita la luce promessa “fu soltanto un sogno ingiustificato, inoggettivo, fonte ora di solitarie, vergognose lacrime” (p. 61).
La disillusione domina e si fa sempre più manifesta.
L’ode “A un ragazzo” –in distici martelliani già utilizzati per “Recit” ne “Le ceneri di Gramsci” – sembra segnare una pausa meditativa ed evocativa nella raccolta. La figura dell’adolescente Bernardo Bertolucci porta il poeta a interrogarsi sul passato recente, a riandare agli anni della Resistenza, al senso di quelle vicende, alla libertà che per il giovinetto è “trovata” e per i padri invece è stata “scoperta”. La sola presenza del ragazzo è domanda, è necessità di spiegare alla nuova generazione il significato di tante lotte, tante morti, “Vuoi che le perdute notti del nostro tempo siano come la tua fantasia pretende, che eroica, com’è eroica essa, sia la parte di vita che noi abbiamo spesa disperati ragazzi in una patria offesa” (p. 66).
Il pensiero del poeta va, con versi di lirismo intensissimi, al fratello Guido morto partigiano, alla stazione dove si salutarono per l’ultima volta in un paesaggio friulano splendidamente evocato, che sottolinea il distacco in una luce di eterno rimpianto. Alle domande dell’adolescente potrebbe però rispondere soltanto l’altro adolescente, rimasto ormai “nella luce del pianto”; “Ah, ciò che tu vuoi sapere, giovinetto, finirà non chiesto, si perderà non detto” (p. 72).
La generazione dei padri non ha più certezze e se ne autorimprovera. È il disincanto, la disillusione, nessun intento pedagogico può essere sostenuto, una stagione si è chiusa e di fronte sembra presentarsi soltanto il vuoto.
Il poemetto “La religione del mio tempo” in terzine chiude la prima parte dell’opera. L’esperienza di una breve malattia, che dà al poeta la possibilità di osservare il mondo esterno dalla finestra , è occasione e spunto d’arte.
Due giovani “ignorati e disadorni”, che “salgono in un sole bianco come neve” i capelli impiastricciati di brillantina rubata ai fratelli maggiori suscitano l’estenuata commozione dell’artista. È un’immagine lirica che pare una sequenza cinematografica.
Di qui un succedersi di rievocazioni del passato, un ritornare dell’immagine iniziale, lo spostarsi della visione fino a Mosca, nei girotondi allegri di ragazzi nella Piazza Rossa e le considerazioni amare sulla realtà presente.
L’atmosfera è malinconica e dolce e la novità del poemetto non consiste nel populismo, nel considerare il popolo come depositario di una vitalità sana e serena, ma semmai nel senso di disillusione di fronte sia all’ideale religioso (di una chiesa povera con i poveri) che a quello politico (ci sono stati i fatti d’Ungheria del ’56).
All’inizio, in una sorta di reverie, il Friuli materno e mitico viene evocato e con esso la giovinezza del poeta, “la mia religione era un profumo…[…] e io qui, perso nell’atto sempre riuscito e inutile, umile e squisito, di scioglierne l’intatto senso nelle sue mille immagini…” (p. 80).
È la dolcezza di quegli anni, le figure dei giovinetti e del popolo contadino, la “lieta miseria” e poi la Resistenza e i suoi valori che soppiantano quelli religiosi tradizionali e paiono poter davvero cambiare il mondo, spazzar via la rassegnazione.
La Chiesa-Potere ha dato solo delusioni: “Guai a chi non sa che è borghese questa fede cristiana, nel segno di ogni privilegio, di ogni resa, di ogni servitù; che il peccato altro non è che reato di lesa certezza quotidiana, odiato per paura e aridità; che la Chiesa è lo spietato cuore dello Stato” (p. 84).
Ritornano poi i giovinetti e le “mattine di pura vita” e la Russia con i suoi figli dapprima lieti, ma “dal lontano futuro disperato”. L’ideale comunista fallirà come quello cattolico, resterà l’amore per la vita in quanto tale, che ha il suo culmine nel quinto lemma, quello in cui viene descritta una nottata in auto con Fellini fin verso Torvajanica di fronte al mare in burrasca. La polemica verso la contemporaneità si accentua, contro coloro che sono cresciuti “in mezzo al branco dei lupi ben adulti;”, vili, tutti uguali.
Si è in vista del finale.
Il neocapitalismo sta avanzando anche in Italia e sta distruggendo e omologando i ceti popolari, che ormai sognano solo il benessere economico, l’imitazione dei canoni borghesi, “il cuore tetramente arreso al quia…”.
Cercano “l’accorato superfluo” e nuova religione di questo tempo è diventata la viltà.
“Così la mia nazione è ritornata al punto di partenza, nel ricorso dell’empietà. E, chi non crede in nulla, ne ha coscienza, e la governa. Non ha certo rimorso, chi non crede in nulla, ed è cattolico, a saper d’essere spietatamente in torto. Usando nei ricatti e i disonori quotidiani sicari provinciali, volgari fin nel più profondo del cuore, vuole uccidere ogni forma di religione, nell’irreligioso pretesto di difenderla: vuole, in nome d’un Dio morto, essere padrone” (p. 99).
Tutto è ormai corrotto dal mito del possesso-sicurezza, la selvaggia speculazione edilizia trasforma la città e le periferie, il distacco si fa sempre più forte nell’animo del poeta “niente di questo mondo umano che io ami. Tutto mi dà dolore”.
La consapevolezza finale è quella della morte di un’ epoca intera.
L’unica poesia possibile sarà quella “incivile” di chi è fuori dalla città, dal Potere, dall’omologazione, di chi è diverso e tale vuole restare, anzi userà questa diversità come arma e come provocazione.
“Sull’onda delle denunce e dei processi «per oscenità» delle sue opere e dei suoi giorni, Pasolini rifiuta in blocco la società nascente del neocapitalismo di massa, insieme a quella già decrepita e clericale, volgare e ipocrita, «spietato cuore dello Stato»” (D’Elia, p. XVI).
L’ appendice a “La religione del mio tempo” contiene versi struggenti dedicati alla madre del poeta, è un omaggio , ma anche un aperto desiderio di morte e definitivo distacco. La chiusa afferma però “non c’è mai disperazione senza un po’di speranza”.
La seconda parte della raccolta è occupata da due sezioni di epigrammi: “Umiliato e offeso” e “Nuovi epigrammi” dedicati perlopiù a critici letterari, a poeti, ma anche alla Francia e a papa Pio XII in occasione della sua morte.
Sono testi sferzanti e acuminati come frecce, dove il sarcasmo del poeta scaglia i suoi strali più vivaci per difendersi e per colpire.
Già il primo, rivolto ai critici cattolici, è indicativo: “Molte volte un poeta si accusa e calunnia, esagera, per amore, il proprio disamore, esagera, per punirsi, la propria ingenuità, è puritano e tenero, duro e alessandrino” (p. 111).
Il tono è la difesa offensiva. Osserva sempre D’Elia nella sua introduzione:
“Anche il primo invito di Pasolini, attraverso l’invettiva di difesa, è a leggere dentro la figura dell’esagerazione del proprio disamore il punto di partenza della passione e della speranza delusa; dentro l’iperbole dell’aridità e dell’amarezza, l’antifrasi della ragione vitale, del canto morale” (p. XVIII).
Il tono generale è quello di una spietata critica ad un’Italia corrotta, borghese, opulenta, ipocritamente clericale. A Pio XII che muore nelle sue stanze vaticane Pasolini contrappone la morte accidentale di un ragazzo plebeo, un manovale, uno dei tanti poveracci che popolano le periferie del mondo sotto lo sguardo lontano di un papa-istituzione, sentito come lontano e disinteressato a quella miseria.
Una nazione che va degradandosi sempre più nelle squallide figure di carrieristi “prefetti codini, avvocatucci unti di brillantina e i piedi sporchi”, borghesi come porci al pascolo, a quest’Italia il poeta augura “Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo”.
In verità è un odio che cela amore, è la rabbia e lo sfogo di chi, nella nazione bigotta e perbenista, ha già subito processi per la sua opera e per la sua persona e cerca ancora di giustificare la propria diversità, prima di quella svolta finale che lo porterà alla difesa intransigente e dichiarata.
Un senso di amarezza profonda lo pervade: “In questo mondo colpevole, che solo compra e disprezza, il più colpevole son io, inaridito dall’amarezza”. (epigramma “A me”, p. 115).
Ai redattori di “Officina”, la rivista bolognese di cui Pasolini fu una delle anime insieme a Leonetti, Roversi, Fortini, Scalia, Romanò, è dedicato uno degli epigrammi più belli. “Officina”, col suo marxismo critico, cesserà per un disorientamento dei redattori (occasione esteriore fu l’epigramma di Pasolini contro Pio XII. La rivista era passata all’editore Bompiani, che aveva amicizie papaline e aristocratiche), ma, di fronte a una realtà incognita, quella neocapitalistica, Pasolini invita a continuare: “Donchisciotteschi e duri, aggrediamo la nuova lingua che ancora non conosciamo, che dobbiamo tentare” (p. 120).
A chiudere la seconda sezione troviamo “In morte del realismo”, lirica d’occasione d’ispirazione shakespeariana, polemica soprattutto verso Cassola, emblema dei “neopuristi” che hanno abbandonato uno stile realistico per restaurare una lingua basata sul culto della forma, spiccatamente autoreferenziale. Pasolini difende invece lo stile “mimetico e oggettivo”, quel realismo dallo stile “misto, difficile, volgare…” che non può essere liquidato avendo lasciato testimonianza nelle opere di Gadda, Moravia, Levi, Bassani, la Morante, Calvino “e una piccola Officina bolognese”.
Le “Poesie incivili”, terza e ultima sezione del libro, si aprono con “La reazione stilistica”, ode dello stesso tono di quella precedente. Siamo nel dibattito letterario, Pasolini critica sempre aspramente i puristi.
“Sono infiniti i dialetti, i gerghi, le pronunce, perché è infinita la forma della vita: non bisogna tacerli, bisogna possederli…” (p. 156).
Il poeta e pochi altri sono soli contro l’atmosfera di restaurazione, di sepoltura frettolosa delle speranze postbelliche. Le antitesi sono tra Lingua/ragione, oscurità/chiarezza. La Lingua è “libero mistero, ricchezza infinita” e non può venire omologata.
“No, la storia che sarà non è come quella che è stata. Non consente giudizi, non consente ordini, è realtà irrealizzata” (p. 157).
La lingua sarà allora ricerca di quel che deve avvenire, sarà macchiata di realtà e non parola assoluta.
Temi ricorrenti sono: il ricordo del Friuli, la Resistenza, il neocapitalismo come nemico ancora da capire, la delusione e la rabbia, la necessità dell’impegno,
“Ho saputo, eccome ho saputo!, che dopo ogni impegno c’è di nuovo il vuoto, e occorre altro impegno…” (p. 162), la poesia.
Il “Frammento alla morte” è dedicato a Fortini e alla fine sembra vagheggiare l’Africa come unica alternativa alla contaminazione che devasta l’Occidente, ma la risposta sarà invece l’opposizione, “la reinvenzione di una poesia ideologica in prosa unica nella cultura degli anni Settanta”(D’Elia).
Sarà poi l’ultimo Pasolini, quello “corsaro” e “luterano”.
Nasce ancora – e da spunti esili (una rosa nel giardino) – la poesia seppure assediata dalla rabbia, da un malessere esistenziale. Tra i rottami della passione il poeta acquista la consapevolezza che non avrà mai pace.
“Il glicine” – che D’Elia nel suo saggio “L’eresia di Pasolini” accosta a “La ginestra” leopardiana – chiude la raccolta: è una meditazione sofferta giocata nel contrasto corpo(passione)/storia.
“Io non so cosa sia questa non-ragione, questa poca-ragione: Vico, o Croce, o Freud, mi soccorrono: ma con la sola suggestione del mito, della scienza, nella mia abulia. Non Marx” (p. 174).
Pasolini vede il popolo trasformarsi: “Altre mode, altri idoli, la massa, non il popolo, la massa decisa a farsi corrompere al mondo ora si affaccia, e lo trasforma, a ogni schermo, a ogni video si abbevera, orda pura che irrompe con pura avidità, informe desiderio di partecipare alla festa. E s’assesta là dove il Nuovo Capitale vuole” (p. 177).
Il ritornare brutale, ad ogni primavera, dei glicini “calchi funerei” che rifioriscono dal vecchio tronco con la loro sensualità e il loro profumo, sono fonte di dolorose riflessioni, il poeta non si ritrova all’interno della società, né in sé stesso, inaridito e stanco, di fronte a un mondo feroce che gli sfugge.
“Ho perduto le forze; non so più il senso della razionalità; decaduta si insabbia – nella tua religiosa caducità – la mia vita, disperata che abbia solo ferocia il mondo, la mia anima rabbia” (pp. 177-78).
recensione apparsa su lankelot.eu nel novembre 2006
Edizione esaminata e brevi note
Pier Paolo Pasolini (Bologna 1922 – Roma 1975) poeta, saggista, regista, narratore italiano.
Pier Paolo Pasolini, La religione del mio tempo, Milano, Garzanti Gli Elefanti 2001. Prefazione di Gianni D’Elia.
Approfondimento in rete: Pagine corsare – Vita e opere di Pasolini / Pasolini-Casarsa / Italica Rai.





Follow Us