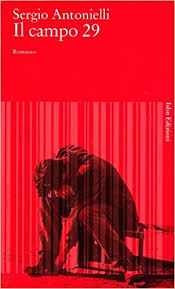
Ci sono porzioni di vita che, parafrasando Seneca, non sono vita, ma tempo. La vita di Massimo Venturi, il personaggio principale e voce narrante de “Il campo 29”, dopo essere stato catturato in Africa e condotto prigioniero ai piedi dell’Himalaya, è divenuta essenzialmente tempo. Tempo da ammazzare, da annientare, da riempire in qualche modo e con qualche occupazione.
Non tutti sanno (nemmeno io sapevo) che durante la Seconda Guerra Mondiale circa 10mila soldati ed ufficiali italiani vennero catturati dagli Inglesi e portati, dopo un lungo viaggio su navi fatiscenti e maleodoranti, in campi di prigionia indiani. Antonielli era stato rinchiuso a Yol, una località del distretto di Kangra, ai confini col Tibet, la stessa in cui ambienta il suo romanzo. Scritto nel 1947, poco dopo il rimpatrio, pubblicato per la prima volta nel 1949, “campo 29” viene riproposto dopo 60 anni, da Isbn Edizioni nella collana “Novecento Italiano”.
“I campi erano quattro: 25, 26, 27 e 28. Il 26 aveva due ali in più, pei colonnelli. Poi c’era l’ospedale coi suoi reparti: denti, medicina, chirurgia, tbc e neuro. E infine c’era il campo 29. Il quale era la metafisica. Quando uno moriva, si diceva: ‘E’ andato al 29′.” Infatti il campo 29, quello indicato nel titolo, non è mai esistito se non nella dialettica, un po’ cinica e un po’ irrazionale, dei detenuti. Nei quattro campi, dunque, sono ospitati, baracca dopo baracca, soldati ed ufficiali dell’esercito italiano ridotti, stellette e mostrine a parte, a prigionieri comuni. Col tempo, infatti, le gerarchie militari vengono cancellate dalle consuetudini di una convivenza forzata. Si stringe qualche amicizia, si scelgono compagni coi quali parlare un po’ più gradevolmente e condividere qualche passione. Riempire le giornate, appelli ed obblighi esclusi, diviene un’emergenza. Quando Venturi giunge nel campo, trova uomini che sono lì già da un paio di anni. Il privilegio di essere un nuovo arrivato dura per un po’, poi sfuma e si appiattisce come è già accaduto agli altri. I prigionieri si sforzano di dare una parvenza di normalità o di libertà ad una esistenza sempre uguale. Difficile. I pensieri diventano velocemente manie fino a sfociare in ossessioni o in sguardi allucinati del reale.
La mancanza di contatti con le donne porta molti a deviare istinti e ruoli. Per questo quando nel campo si allestiscono spettacoli teatrali, le “attrici”, che non sono altro che soldati truccati e vestiti da donna, vengono ammirati e corteggiati come fossero donne vere. Certi limiti si sfaldano fino a tramutare l’uomo in altro da sé.
“Bisognava resistere, magari per andare a morire in Italia, per aspettare il momento buono per riattaccarsi alla vita e voler bene al prossimo, a noi stessi, a nostra madre che ci ha messi al mondo“. La morte è una seduzione per qualcuno. Il suicidio la via più breve da attuare nel buio di un locale per docce, per farsi scoprire cadaveri solo al mattino successivo. Resistere è un imperativo che Venturi e i suoi compagni cercano in ogni modo di rispettare. Prima o poi dovrà pur cambiare qualcosa. Le notizie arrivano sempre in ritardo attraverso lettere spedite mesi prima e recapitate con difficoltà. Parole che arrivano ad interrompere l’accidia di un microcosmo che appare perennemente paralizzato ed indifferente. I prigionieri possono uscire qualche ora al giorno restando attorno al campo, passeggiano, parlano tra di loro e non possono avere contatti con l’esterno. L’India c’è ma è descritta in maniera distratta. E’ fatta di facce sporche, odori infelici, donne colorate e sciatte come vermi e ragazzini che vendono favori sessuali per qualche moneta. Una terra che viene raccontata per frammenti e senza alcun trasporto. E’ un Paese che diventa barriera in sé perché comunque lontanissimo dall’Italia e diverso sotto ogni punto di vista.
Nel romanzo di Antonielli si annida tutto il disfacimento a cui conduce la guerra e la detenzione, sua possibile conseguenza. Si racconta la vita sospesa di chi è costretto e reinventarsi un ruolo all’interno di uno spazio obbligato e ristretto. L’urgenza di non farsi annichilire dalle ore consumate per niente diviene necessità predominante di un’esistenza. Eppure, nonostante tutto, questo libro non mi ha catturata, non è riuscito a generare empatia, ha tenuto in sospeso la mia complicità per abbandonarla, sfinita e demotivata, nelle ultime righe. Antonielli pecca di un certo manierismo che scalda appena una storia che avrebbe potuto o dovuto infiammare chi la legge. L’autore prende blandamente le distanze da una materia che, in verità, ha conosciuto e saggiato sulla propria pelle e che speravo affrontasse con maggiore coraggio. Rimane un po’ troppo in superficie o volutamente all’esterno dell’orrore dell’esperienza che ha vissuto. Ed è un peccato.
Edizione esaminata e brevi note
Sergio Antonielli è nato nel 1920 a Roma. E’ stato un importante critico letterario italiano. Come narratore ha pubblicato: “Il campo 29” (1949), “La tigre viziosa” (1952), “Un cane e un uomo in più” (1958), “Il venerabile orango” (1961) e “Oppure niente” (1971). Antonielli è morto a Monza nel 1982.
Sergio Antonielli, “Il campo 29”, Isbn Edizioni, Milano, 2009.





Follow Us