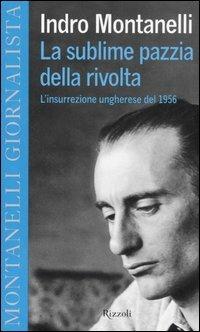
“Dovranno trascorrere molti anni perché anche i comunisti italiani riconoscano il valore democratico di quella infelice battaglia combattuta e persa a Budapest. Montanelli lo aveva capito prima di noi”. Così Miriam Mafai nella prefazione a “La sublime pazzia della rivolta”, raccolta completa delle corrispondenze di Montanelli dal fronte della cosiddetta Rivoluzione ungherese del 1956. La Mafai, donna di sinistra, scriveva nel 2006 quando ancora il nome di Montanelli, col pretesto del suo antiberlusconismo, era spendibile anche dai cosiddetti progressisti. Poi sappiamo come sono andate le cose. Rimane il fatto che gli articoli del giornalista toscano raccontavano una realtà ungherese molto diversa sia da come, al tempo, veniva immaginata dai comunisti di Togliatti, sia dall’opinione pubblica “moderata” o di “destra”, di cui Montanelli ha fatto sempre parte.
Inviato dal Corriere della Sera, arriva a Budapest il primo novembre 1956 in tempo per vedere la ritirata dei carri armati russi; e di conseguenza conosce l’entusiasmo dei patrioti ungheresi, illusi di un futuro indipendente e neutrale. Poco dopo però, in compagnia di pochi altri inviati occidentali, assiste alla fulminea occupazione sovietica della città, alla disperata battaglia degli ungheresi. Rifugiatosi fortunosamente a Vienna, inizierà a raccontare la cronaca della battaglia di Budapest, con tutte le ciniche premesse che avevano portato a quella repressione violenta: gli intrighi della politica internazionale, le ambiguità di Tito, i raggiri di Kruscev, le cautele di Nixon, l’inerzia delle democrazie occidentali, al tempo ben più interessate alla crisi di Suez. Ma soprattutto racconterà chi erano davvero gli ungheresi che si erano strenuamente battuti contro le soverchianti truppe sovietiche. Da questo punto di vista ancora una volta Montanelli confermò la validità del suo nome di battesimo, Schizogene, ovvero “generatore di conflitti”. Comprese infatti che i rivoltosi ungheresi non erano né reazionari fascisti, come propagandato da Mosca e dal P.C.I., e nemmeno dei democratici in lotta contro l’ideologia comunista: “Chi li ha visti, come li ho visti io stanotte, questi poveri fanti improvvisati e scalcagnati emersi dalle università, dai licei, dai campi, dagli uffici e dalle fabbriche, con gli arcaici fucilini, imbracciati come se fossero altrettanti cannoni, e senza nemmeno essere allenati a maneggiarli, al passaggio di quei mostruosi e terrificanti panzer, di cui non avrebbero potuto scalfire nemmeno un cingolo, non può aver dubbi in proposito. Questa è gente che non scappa più, che non si arrende più, nemmeno alle ragioni della ragione” (pp.36).
Era piuttosto un popolo di cultura socialista, che credeva nel vecchio comunista Nagy, ma che soprattutto voleva vivere in un paese libero, indipendente e neutrale. Scrivendo questa realtà, ovvero una rivolta di comunisti contro la nomenklatura sovietica, indigesta sia a destra che a sinistra, si ritrovò contestato, non soltanto dai comunisti di Togliatti, al tempo sempre allineati con l’Urss, ma anche dai suoi amici destrorsi. Celebre fu la sua rottura con Leo Longanesi.
Questi articoli, considerati – almeno fino a poco tempo fa – da molti colleghi e studiosi dei “pezzi memorabili”, potrebbero sorprendere il lettore contemporaneo sotto diversi aspetti. Innanzitutto per l’immedesimazione, il pathos che si coglie in ogni riga, ben diverso dalla freddezza cronachistica dei nostri contemporanei. E poi su tutto, considerando che si viveva in piena guerra fredda, la convinzione più scandalosa: “A Budapest il comunismo è morto: lo dico con profonda convinzione. E non c’è artificio dialettico che possa risuscitarlo. Di esso non rimane che un esercito irto di cannoni, che sparano contro gli operai, gli studenti e i contadini. […] Ma è morta, a Budapest, anche la nostra “reazione”. Non ce n’era sulle barricate, fra i protagonisti del più bello e nobile episodio della storia europea di dopoguerra. Non ce n’era né in senso fisico, né in senso metafisico. La libertà e il socialismo che irrigidivano quelle folle nere e silenziose, compatte come macigni, contro il sopruso e l’aggressione, sono una religione nuova, incubata in un decennio di sofferenze, di cui noi non abbiamo l’idea, e che un giorno ci conquisterà: non facciamoci illusioni. Non perché essa porti “istanze” più moderne e originali, programmi più validi e arditi; ma perché porta, nell’affrontare i problemi, una serietà, un impegno, una decisione, una devozione, insomma un clima morale, di cui noialtri occidentali s’è perduto il ricordo. Ecco: questo era l’esame di coscienza che si imponeva, con identica perentorietà, alla “Pravda” e a noi. Noi lo abbiamo fatto. La “Pravda” non può (“Esame di coscienza dinanzi al popolo ungherese”, 25 novembre 1956).
Peraltro attualmente sono molti gli editorialisti e gli “influencer” politicamente impegnati, che ci raccontano quanto fosse infame non soltanto il Montanelli uomo ma anche il Montanelli giornalista. Come contrastare questa narrazione, che, secondo qualche malfidato, scaturisce semmai da scarsa conoscenza dei fatti, da pregiudizi e magari anche da qualche punta di invidia? Invitare a leggere “La sublime pazzia della rivolta”, come altri famosi reportage, e forse qualcuno tra quelli che, senza mai leggerlo, hanno preso per buono quanto scritto e detto dai loro “influencer” di riferimento, potrebbe cambiare idea almeno sul Montanelli giornalista.
Edizione esaminata e brevi note
Indro Montanelli, (Fucecchio 1909 – Milano 2001), giornalista. Inviato speciale del “Corriere della Sera”, fondatore del “Giornale nuovo” nel 1974 e della “Voce” nel 1994, è tornato nel 1995 al “Corriere” come editorialista.
Indro Montanelli, “La sublime pazzia della rivolta. L’insurrezione ungherese del 1956”, Rizzoli (collana “Montanelli giornalista”), Milano 2006, pp. 187. Prefazione di Miriam Mafai.
Luca Menichetti. Lankenauta, maggio 2023





Follow Us