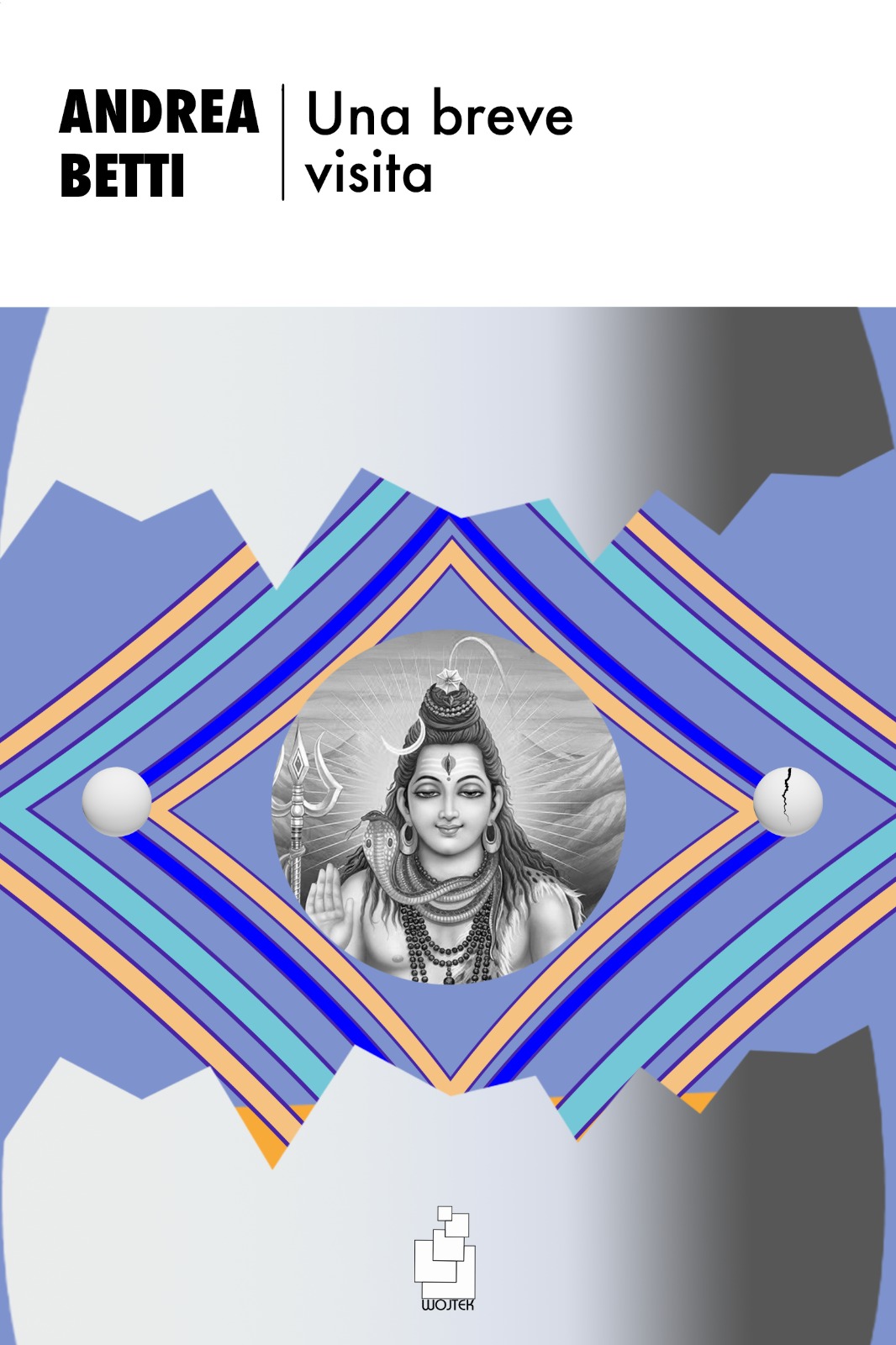
Andrea Betti ha da poco esordito con Una breve visita, romanzo breve pubblicato da Wojtek, una casa editrice fondata nel 2018 che nel giro di questi 4 anni è riuscita a mettere in piedi un catalogo di tutto rispetto. Una breve visita è un libro piuttosto curioso, Andrea una persona molto disponibile, così abbiamo conversato toccando vari punti, da come è arrivato alla pubblicazione ai temi presenti nel libro, finendo persino un po’ più in là.
D: Andrea, come sei arrivato alla pubblicazione? In rete ci sono vari tuoi testi e hai preso parte anche ad antologie cartacee, ma mancava un libro solo tuo. Di solito si arriva dopo anni di tentativi a trovare uno sbocco tra le tante case editrici presenti in Italia. In tempi relativamente recenti sono nate scuole e corsi di scrittura e si è cominciato a notare anche una presenza più diffusa delle agenzie letterarie, che fanno da intermediarie tra chi ha scritto e le case editrici. Per te com’è andata? Hai avuto un percorso, diciamo, solitario (intendo dire con questo se hai scritto e, finito il testo, hai spedito e poi ti hanno accettato) o ci sono stati passaggi intermedi come corsi, scuole, agenzie?
R: Ciao Andrea, grazie dell’ospitalità di Lankenauta e tua, innanzitutto. Provengo da una lunga, sotterranea e appassionata militanza nel mondo dell’autoproduzione letteraria e dei reading. In principio fu AssCultPress, negli anni Novanta, entità anomala di cui sono stato furioso performer e cofondatore con Simone Molinaroli, Jacopo Andreini e David Napolitano. Con ACP in collaborazione con Dizlexiqa di Lorenzo Giuggioli, Milano, ho pubblicato tramite piattaforma crowdfunding La felicità terribile/Zucchero spinato la mia prima raccolta di poesie e scritti…ripubblicato, in realtà: la prima edizione autoprodotta, senza la corposa appendice di “Zucchero spinato”, fu data alle stampe negli anni Novanta in tiratura limitatissima, il famigerato (per chi lo conoscesse) librino con la copertina tutta nera. Il mio rapporto con i social è complicato; ne sono stato a rota per un lungo periodo; quattro anni fa me ne trassi fuori e solo di recente, dopo la pubblicazione del romanzo, mi sono ricreato un profilo facebook, per rintracciare la mia vecchia rete di conoscenze e coloro che sto incontrando durante le presentazioni; conservo il mio primo ed unico blog “Hamonveg” più volte cancellato e riscritto, abbandonato e poi ripreso, dove ogni tanto scrivo ancora: lo considero la mia palestra. Circa quattro anni fa ho iniziato a frequentare i corsi pomeridiani della Scuola del Libro di Vanni Santoni: il mio percorso di studi e professionale c’entra ben poco con la letteratura. Ho studiato industrial design all’ISIA di Firenze, dove ho conseguito, tanto per non smentirmi, un diploma da eretico: non ho discusso infatti una tesi di design del prodotto, ma su “VJing e New Media”. Essenzialmente mi sono sempre occupato di graphic design (in particolar modo packaging) ma per un periodo ho affiancato a questa attività, quella artistica nell’ambito del vjing / videoinstallazioni in maniera piuttosto remunerativa e gratificante; per tale ragione quello dell’arte contemporanea è un tema ricorsivo nel libro, incarnato dalle figure caricaturali dei due galleristi snob; come ti raccontavo durante il nostro incontro di qualche giorno fa, Una breve visita è uno scritto che mescola il memoir alla fantascienza. Sempre nel periodo che frequentavo il corso di Santoni, sono stato selezionato per due edizioni di fila, purtroppo senza alcun esito editoriale, agli incontri di scouting di “L’Anno che Verrà”.
Il susseguirsi di questi accadimenti positivi, nonostante i rifiuti ricevuti, fu molto incoraggiante e, un paio di anni dopo, a cavallo della pandemia e del primo scioccante lockdown, ho esordito in due progetti editoriali collettivi: Tina: storie della grande estinzione (Aguaplano) a cura di Matteo Meschiari e Antonio Vena, un libro-mondo che ospita più di centocinquanta fra scrittori e illustratori coinvolti in un lavoro di ridefinizione dei canoni della narrativa sulla base dello shift cognitivo scatenato dalle molteplici e imprevedibili occorrenze dell’Antropocene; per questa opera scrissi un micro-romanzo di cinquemila battute esatte, ma in osservanza alla regola del gioco che ci eravamo dati, non posso indicartene il titolo; e, contemporaneamente, su La scommessa psichedelica (Quodlibet) a cura di Federico di Vita, con un saggio molto critico verso il cosiddetto Rinascimento Psichedelico, su invito di Vanni Santoni che lo aveva letto in forma rough in uno dei nostri scambi di battute su messenger a tema psichedelia. In seguito a queste due prime uscite presi contatto con molti intellettuali, scrittori e operatori del mondo dell’editoria; fra questi, quella che sarebbe diventata la mia agente, Sylvie Contoz. Ci siamo conosciuti a seguito di uno scambio di battute fra i commenti a un mio post: mi chiese di inviarle in lettura il romanzo su cui lavoravo da alcuni anni e decise di rappresentarmi. È stato indubbiamente per merito suo e della sua instancabile e ben calibrata promozione del mio lavoro letterario che sono entrato in contatto con Wojtek. Anche Wojtek, a un secondo livello di lettura, rifiutò quel romanzo laborioso, ma nonostante ciò non mi precluse possibilità di pubblicazione, anzi rilanciò con una sfida, investendo sulla mia scrittura e mi fu proposto di lavorare a un nuovo progetto from scratch. Affiancato dal formidabile Alfredo Zucchi, in veste di editor, cominciai l’avventura di Una breve visita: nata come una nouvelle, in corso d’opera si è espansa, prendendo la forma di un romanzo un tantino più lungo, non lunghissimo, di sicuro viscoso, atipico (o almeno queste sono le prime impressioni che ho ricevuto). Era un’idea che mi girava in testa dal 2016, nata dalle discussioni con la mia ex-moglie Cecilia, anche lei appassionata di fantascienza, ma mi rendo conto che sto già iniziando a rispondere a un’altra domanda e mi stoppo…
D: Una nota su “L’anno che verrà”: un festival letterario pistoiese che permette/va l’incontro, tramite selezione, con scout di case editrici.
Dunque autoproduzione, vjing, reading, corsi e poi l’incontro con un’agente, da qui l’editore. La prima parte (a parte il vjing, davvero interessante) più anni ‘90/primi anni ‘00, mentre la seconda più caratteristica degli ultimi anni. Curioso però il fatto che l’incontro con l’agente sia stato propiziato da un post sui social, così come l’editore che decide di puntare sulla tua scrittura per un progetto ex-novo dopo averti rifiutato un romanzo. Dunque una scrittura capace di incuriosire e creare aspettative: un buon auspicio per il futuro. Dal futuro alla fantascienza è un attimo, e tu l’hai citata nella tua risposta insieme al memoir in un accostamento insolito. Dopo la “autobiografia horror” (Leggenda privata di Mari) ecco il “memoir fantascientifico”? (“fantascienza memorialistica” mi sembra più lontana dalle tue intenzioni). Una breve visita parla di un monaco che raccoglie voci e testimonianze su un fatto di secoli prima: la venuta sul nostro pianeta di umanoidi, i “Cilestrini”, per un fine settimana. La fantascienza è ben evidente, ma il memoir si nasconde. A una presentazione del libro a cui sono stato si è parlato anche di ucronia, distopia e utopia. Se si aggiungono a memoir e fantascienza ecco 5 generi in un romanzo che non raggiunge le 200 pagine. Più che un libro fisico, un liquido che prende la forma a seconda del punto di vista da cui lo si guarda (legge). Volevi fin dall’inizio giocare fra tutti questi generi o è stato qualcosa di cui ti sei reso conto solo alla fine? Ci vuoi parlare inoltre del nucleo originario dell’idea e di come il lavoro di scrittura, anche con l’editor, l’ha sviluppato? Come è venuta fuori questa struttura di voci.
R: La mia ragazza ha notato che tendo a non rispondere nel merito delle domande: parto per la tangente e mi lascio trascinare da un turbine di associazioni. Le ho spiegato che facevo così anche durante le interrogazioni a scuola. Molte volte l’affabulazione mi ha tratto in salvo: scavallavo la risposta diretta, portavo altrove la discussione. Non lo faccio con malizia: così è anche il mio modo di scrivere e di essere al mondo. Ma cercherò di essere preciso stavolta. Tu osservi giustamente che il memoir è sottotraccia: lo è perché per rendere universale il personale, perché il lettore possa identificarsi nelle inevitabili similitudini delle nostre vite (l’amore, il lutto, la malattia ecc…) non necessita di diventare un esegeta della vita di Andrea Betti, cosa può importargli? Cosa può fregare a me di renderlo partecipe delle mie personali vicende? Ma sicuramente potrà riconoscersi nei mood, nelle situazioni, nelle dinamiche di affezione fra i personaggi, nelle loro gioie e nei loro affanni, nell’idea del diario intimo, che nel mio caso, non sempre ma spesso, attinge a fatti che mi sono realmente accaduti (avevo per davvero un nonno falegname-restauratore, tanto per fare un esempio). La fantascienza come “immaginazione tecnica” (come la definì Francis Bacon in una memorabile intervista dialogo con Marguerite Duras) è il distorsore che mi è più congeniale – anche per ragioni autobiografiche, considerata l’attrazione che provo per questo genere fin dall’infanzia – dove l’input del mio vissuto viene compostato in immaginario. Il libro è liquido (mi verrebbe da dire: quale non lo è?), condivido la tua analisi, e dà a sua volta al lettore la possibilità di ricrearsene nella propria immaginazione, una personalissima versione, così come in ambiti più colti, si dibatte sul significato di antichi frammenti rinvenuti ai piedi di una ziggurat, perché la memoria anche recente, personale, non solo quella di specie, è una trama esile, lacerata in più punti, talvolta ricostruita in maniera strumentale, un tessuto cicatriziale fibrotico, nel quale letture e ricuciture di epoche e momenti successivi si sovrappongono, si infettano. Quindi, è sì un liquido, ma denso; una colatura (una percolazione) di molti di quegli elementi che tu hai citato e che ho compresso con l’escamotage del racconto per frammenti (apparentemente) scollegati, che mi permetteva tramite ampie ellissi di toccare i temi dell’ucronia, della distopia, dell’utopia e del memoir fantascientifico (ti ringrazio per questa definizione puntuale) senza bisogno di scrivere più di quel che è stato scritto. Considera anche che fra paragrafi tagliati per intero, e altro materiale scartato, revisioni e riscritture, forse oggi avresti fra le mani un volume di almeno trecento o quattrocento pagine. Questo lavoro di taglio è stato eseguito “chirurgicamente” soprattutto grazie al puntuale lavoro di revisione editoriale di Alfredo Zucchi: mi ritengo molto fortunato ad aver iniziato con Alfredo la mia esperienza. Abbiamo lavorato per più di un anno a strettissimo contatto (anche se non ci siamo mai incontrati fisicamente); lunghe telefonate, fitto scambio di mail e messaggi su whatsapp, revisioni e riletture a cadenza quasi settimanale in principio, poi man mano che il libro assumeva la sua fisionomia, più diradate nel tempo. Ho apprezzato moltissimo di Alfredo la disponibilità, il gusto, l’intelligenza, la creatività sinergica, mai invadente, rispettosa della mia voce e a questa “consacrato” – come editor, perché Alfredo è anche romanziere e saggista, con la sua voce, il suo modo di scrivere e narrare – per farla uscire al meglio, nelle sue peculiarità. Il racconto polifonico e su più registri è intenzionale, programmatico direi quasi, e fu su questa scelta che è stata modellata l’idea originale che esisteva sotto forma di una sorta di sinossi, più un foglio di appunti, scritto nel 2016 per fissare il concept della “Visita”, nel quale venivano abbozzati alcuni dei personaggi principali (Guinevere e Marcus, il professor Amirani, Ajuricaba e Ippolita, il movimento RAD e il movimento SVA) lo svolgersi della trama, i suoi fotogrammi chiave. Per riuscire in questo succinto e “zippato” worldbuilding che doveva stare nel canone della nouvelle (poi infranto) era l’unica via. Offro al lettore che – mi auguro sia – disorientato alcuni strumenti: la dramatis personae iniziale, le note (alcune vere, alcune fuorvianti – del resto è lo stesso monaco narrante che ha una memoria lacunosa dei fatti e deve ricostruire cinquecento anni di storia partendo da pagine sparpagliate, da registrazioni smagnetizzate dal cut-up del divenire) e il Manuale del Kiberneta Meticoloso che si può leggere a parte: una mappa, un prontuario da consultare alla bisogna, del mondo di Una breve visita. Non ultime, sottotraccia quanto il memoir, sono le citazioni occulte, gli easter eggs come si chiamano in gergo: sono disseminati un po’ dappertutto, e sarà piacere del lettore (se non sarà un fastidio) rintracciarli, indovinarli. Mi sono ispirato in questo a Player One di Ernest Cline, romanzo collage/hommage alla cultura anni Ottanta, quasi interamente costruito su citazioni di film, libri, fumetti, videogames amati nella sua adolescenza.
D: Le divagazioni secondo me servono ad allargare la visuale, anche se possono disorientare, e in fondo le interviste, le conversazioni, trovo che siano divagazioni più o meno guidate, cercando di arrivare altrove. Torno così all’inizio del tuo romanzo, con il monaco kiberneta: “Questo, ch’io sono, è solo uno dei narratori chiamato a raccogliere le briciole… Questo, ch’io sono, si farà da parte d’ora in poi – non sempre, non del tutto – …”. Capiamo così che lui è solo uno dei tanti, e noi siamo testimoni della costruzione di un testo sacro, ne leggiamo la parte da lui raccolta e commentata. Forse si può paragonare al Nuovo Testamento, per la varietà di voci, di tempi. Forse un testo sacro, appunto, ma ecco che la presenza del Manuale fa diventare il romanzo un gioco, con le pedine/personaggi e il manuale di istruzioni. Al centro i Cilestrini, con la loro indifferenza verso di noi. Indifferenza che fa da spartiacque: il Prima e il Dopo, la loro deità, da cui i fedeli e i non, l’attesa del ritorno etc. Indifferenza che getta l’umanità nello sconforto, la fa slittare di posto: non abbiamo più il privilegio del rapporto con dio. Il Cilestrino ha preso la sedia su cui eravamo seduti, siamo caduti e non gli interessa. Siamo infanti che reclamano attenzione. Non solo fantascienza, utopia, distopia, ma il comico, il tragico, l’umoristico. Una riflessione sul sacro (Treccani: enciclopedia; vocabolario), sulle religioni, sull’uomo vitruviano, sull’umanità. Ma non è così serio, rimane un gioco, con un Manuale. Un gioco sacro. Dei Cilestrini. Un’ellissi, i cui due fuochi possono cambiare a seconda di ciò che si va a indagare: umorismo e tragedia; ucronia e distopia; fantascienza e memoir… (tante le combinazioni possibili). Se prendo fantascienza e sacro penso a Dune, per esempio. Tutto questo, se c’è e non sono del tutto mie elucubrazioni, è stato costruito con quei tagli chirurgici? Altrimenti avremmo avuto un testo più sbilanciato? Divagando oltre, sui social tu stai pubblicando parti tagliate (immagino), accompagnate da immagini create con MidJourney, una Intelligenza Artificiale Text-To-Image. Avevi realizzato anche un trailer, se non erro, con una base musicale. Com’è, per te grafico e scrittore, creare immagini del tuo romanzo con un programma di questo tipo? Quanto si avvicinano i risultati a ciò che immaginavi quando l’hai scritto? L’accompagnare con immagini i testi che stai pubblicando toglie o aggiunge qualcosa? Per certi versi, l’immaginazione di chi legge è aiutata, guidata, meno libera, o no?
R: Ti rispondo a ritroso: MidJourney (MJ) è per me gioco ed esperimento. La curiosità, innanzitutto di vedere, partendo da descrizioni testuali, arricchite da dettagli di stile, come un’intelligenza artificiale avrebbe raffigurato personaggi, luoghi e situazioni del romanzo. Questo esperimento ha creato una serie discreta d’illustrazioni (che per altro il prompter evoluto troverebbe persino un po’ naïf, ma a me interessava più che la perfezione o l’aderenza ad una mia idea preconcetta dei personaggi ecc… una creazione della macchina, o un trovarsi a metà strada, fra il prompt dove talvolta copiavo incollavo brani del libro tradotti in inglese con pochissime indicazioni stilistiche e la “libera” interpretazione dell’algoritmo). Le illustrazioni quindi le ho montate in un video, che utilizzo quando possibile, come commento “visuale” alle presentazioni, come pretesto per innescare domande nel pubblico o per parlare delle TTI (Text to Image) intorno alle quali si sta scatenando, come sempre è accaduto rispetto a tecnologie rivoluzionarie, un acceso dibattito fra chi le detesta e teme possano togliere lavoro agli illustratori, grafici e artisti umani, e chi invece ritiene che siano un nuovo e portentoso strumento che trova compiutezza proprio nell’interazione umana. Jeff Vandermeer ha dichiarato in un post su facebook che non userà mai una AI per la copertina di un suo libro. Una posizione legittima, ma io sono più propenso a credere che le immagini generate da MJ et simili, possano essere considerate materiale grezzo da cui ricavare spunti; oppure, altro scenario suggestivo, anche vertiginoso o inquietante se vuoi, siamo testimoni dei prodromi di un’operatività collaborativa umano-macchina nella quale, come osservato da Magini in un recente articolo, non si veda dove inizia l’uno e finisce l’altra.
Il prompter è una figura quasi mistica, un monaco Kibernetes nel vero senso della parola, scrittore di sogni-programmi che l’entità non-umana trasforma in figure; un tramite, il medium con un aldilà macchinico. L’eccezionalità rispetto a strumenti del passato pur rivoluzionari (la stampa a caratteri mobili, la macchina a vapore, l’aereo, il computer stesso…) è che l’algoritmo è uno “scritto”– che la civiltà abbia inizio e conclusione con la scrittura?– uno script che interpreta e per quanto, partendo dal testo si voglia un’immagine il più fedele possibile a questo, rimane sempre un fondo d’imponderabilità. Siamo agli albori di una scelta cosciente non umana, o si tratta di mero calcolo statistico e sintesi dei miliardi di esempi contenuti nel dataset? E noi umani come funzioniamo quando creiamo qualcosa ex-novo? Non abbiamo anche noi sintetizzato un ampio “dataset” di informazioni? L’unica tangibile differenza risiede a questo punto nella nostra emotività, nell’agire motu proprio, spinti da un’ispirazione, una compulsione, un ragionamento, da qualsiasi motivazione, ma personale…
Seppur non intenzionale (l’input umano è imprescindibile alla genesi delle immagini) l’“agentività” delle TTI rispetto a strumenti esistenti raffinati ma passivi, apre a possibilità inedite e perturbanti, a una ridefinizione dei ruoli di artista, illustratore, scrittore… del “creativo” (parola uggiosa) in genere.
Apripista in tal senso credo sia stata la musica, forse per la sua natura “impalpabile” e astratta: un ambito di creazione che da tempo ha implementato macchine generative, processi aleatori, contemplato profili iperstizionali (sto pensando a Kodwo Eshun, all’Afrofuturismo, al suo fitto dialogo con gli accelerazionisti della CCRU; all’idea, ripresa da Nick Land, della drum’n bass, come anomalia temporale, musica proveniente dal futuro, musica macchinica per esseri umani già prevalentemente macchinici in ogni aspetto della loro vita).
Poi che ti devo dire? Io sono uno “stupido accelerazionista” (qualcuno, non ricordo dove, ha definito così noi “entusiasti”) e dacché ho memoria il gioco delle ricombinazione casuale, oppure non casuale ma ardita, vertiginosa fra elementi in contrasto, mi ha sempre divertito: i giochi di parole, i nonsense, i sacchetti dadaisti; il programma che David Bowie commissionò per generare frasi random partendo da alcune parole chiave che l’artista forniva al computer; nessuno dei profluvi post-dada generati dal programma è infine diventato il testo tout-court di una canzone, ma alcune frasi estrapolate sono state d’ispirazione per l’artista. Lui ne faceva pure un discorso di economia di tempo e salute: era più comodo, più veloce, affermava – e meno gravoso fisicamente – indurre certe bizzarre associazioni d’idee con un software, anziché sbronzarsi e/o assumere cocktail di sostanze varie, trascorrendo nottate brave da ripagare con la moneta ingrata dell’hangover o di perniciose dipendenze (eccezion fatta, ci tengo a ribadirlo, per gli psichedelici, che pur non generando dipendenza, sono sicuramente molto impegnativi come investimento di tempo ed energie fisiche).
Sarebbe concettualmente più forte lasciar fare tutto alla macchina, indovinarne il fantasma che la agita sotto le mentite spoglie del “caso”, ma alla fine ozioso: non per me che amo queste sperimentazioni estreme sui linguaggi e i media, tipo i film di otto ore con un tizio che dorme di Warhol, le sperimentazioni di Grifi ecc… c’è un rigore dell’alea, secondo me associabile a quel concetto di “rispetto del materiale” che ci insegnavano ai corsi di progettazione dell’ISIA, che mi risveglia l’attenzione sui dettagli, che mi scionna e disattiva il default mode network del cervello. A me piace, perché questo genere di stimoli, al pari di certi eventi inattesi del vivere, ritengo ci rendano ricettivi, ben disposti verso una creatività “tutta umana” con buona pace dei “luddisti” di sempre. L’esperimento MJ su “Una breve visita” così come la generazione di contenuti accessori, spin off, ecc… sono un corpus che sto creando per mio piacere, strascichi di un’ondata creativa che ancora non si è esaurita, piccoli doni che faccio di tanto in tanto ai lettori; adesso mi sono un po’ fermato, per evitare che la mia insanabile compulsione mi facesse sommergere il lettore di contenuti non richiesti. Ne ho già scritti un po’ e per il momento se ne stanno lì nel loro guscio a covare: mi piace molto l’idea di “disseminazione” alla J.J. Abrams ma è una strategia che acquisisce valore solo se deriva da una precedente curiosità, dalla suspense dovuta all’attesa, una fame di ulteriori dettagli. Ciò non mi impedisce di sperimentare altri sviluppi a livello “esoterico” o come esercizio di stile; di ricorrere a rimandi infratestuali fra scritti diversi e autonomi fra di loro; a elementi ricorsivi che popolano il mio immaginario, ma si tratta più del mio modus operandi di essere scrivente. Essere al servizio del proprio esordio è il mio compito prioritario adesso ed è per me una prova di temperanza, talvolta ardua; caratterialmente ti dico, manco di reticenza, di vuoti, delle necessarie sospensioni, dei silenzi, che per me sono possibilità di altro da dire, da riempire: di certo in questo non faccio mio, lo “Zero is Immense” Landiano, o il concetto di poromeccanica di Negarestani, e visto che lo citi, nemmeno lo sconfinato deserto di Arrakis (Dune).
Pur trascorrendo lunghi periodi di totale immobilità, l’acqua in fondo alla pentola comincia a bollire, fa emergere increspature sulla superficie fredda: sono un indemoniato (!) o meglio, uno spossessato. Nella connotazione dei Cilestrini indifferenti credo di aver introiettato la disattenzione ricevuta: in fondo sono io l’essere umano che viene ignorato. È piuttosto avvilente, vero? Un po’ patetico anche: potrei seguire il consiglio di uno dei protagonisti di Contact di Carl Sagan; nella riduzione cinematografica di Zemeckis, Kent, un radioastronomo cieco, cercando fondi per il progetto SETI afferma che “mendicare fa bene all’anima”. Potrei far mia la sua massima, ma l’elemosina è una pratica che richiede sobrietà, compostezza in corpo e spirito, l’esser saldi nel proprio svuotarsi, zero aspettative, un totale affidarsi al caso, una dignità, una concentrazione che non mi appartengono.
Mi piace molto l’immagine dei due fuochi dell’ellissi cha hai usato e la trovo calzante rispetto ai due movimenti antitetici del romanzo (distopia/utopia) che si uniscono in un’unica linea continua. Ho tagliato in segmenti questa linea, certo per gioco, e giocando qualche segmento si è perso nel Radiokaos, ma a buon fine. Sì: sono convinto che sarebbe stato un testo più sbilanciato, il che non sarebbe un male in senso assoluto se penso alla feconda incompiutezza di Infinite Jest, libro senza inizio e senza fine, composto da sottotrame, racconti, note, anch’esse incompiute.
L’incompiutezza è materia fissile per titani, l’opera “ampia e insoluta” di Schifano, rifuggire risposte almeno quanto si bramino nuove domande: richiede un approccio Fremen – restando a Dune – confidenza col deserto di Arrakis, con lo zero immenso, il superamento dell’horror vacui, la vittoria sulla compulsione. Ci devo ancora lavorare molto ed è arduo per me, perché vivo in una costante percezione di mancanza di tempo; forse il lavoro di grafico con le sue urgenze e consegne rapide di materiali ripetitivi ha minato la mia già esigua ponderatezza. Talvolta dico ad amici che vivo nel “tempo mosca” o per consolarmi – ma è un’idea che a me piace – che il tempo non esiste, esiste solo lo spazio.
“Spazio, ultima frontiera”.
Sono le parole iniziali degli episodi, dei film di Star Trek, ma calzano a pennello anche per questo finale sospeso, incompiuto, sperando di aver divagato verso nuove domande sul romanzo Una breve visita, ma non solo. Grazie alla disponibilità e alla pazienza di Andrea Betti.
Edizione esaminata e brevi note
Andrea Betti, detto anche Tibet, è nato ottantatré anni nel Prima, nella seconda metà del Secolo Nucleare. Cofondatore di AssCultPress (con Jacopo Andreini, Simone Molinaroli e David Napolitani) si produce in furiosi reading in tutta Italia fino ai primi anni del Secolo Acidificato; ha pubblicato saggi e racconti apparsi, online, su «Nazione Indiana» e «LGE – La Grande Estinzione», e su carta, all’interno del progetto di narrazione collettiva TINA – Storie della Grande Estinzione (Aguaplano, a cura di Antonio Vena e Matteo Meschiari) e di La Scommessa Psichedelica (Quodlibet, a cura di Federico di Vita).
Andrea Betti, Una breve visita, collana Orso Bruno, Wojtek





Follow Us