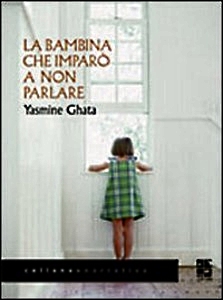
“Muettes”. E’ questo il titolo originale de “La bambina che imparò a non parlare”. Muettes vuol dire mute. Mute come le protagoniste di questo interessante e breve romanzo di Yasmine Ghata. Una madre, una figlia e un lutto lacerante, la perdita dell’uomo di famiglia, marito della prima, padre della seconda.
Non conosciamo i nomi di queste due figure femminili ma, d’altro canto, non se ne avverte la necessità. Il loro mutismo, che è poi quello del titolo francese, è generato dalla perdita, dall’abbandono inaspettato, non voluto ed asprissimo.
La madre tace il proprio dolore, incapace persino di comunicare a sua figlia la notizia del tragico evento. Parole che non le arrivano mai ma che la bambina, io narrante ed alter-ego della Ghata, percepisce ugualmente attraverso i gesti e l’inespresso materno.
Tra la donna e sua figlia c’è una quotidiana repulsione, un rigetto amaro che però, durante la notte, al buio completo, diviene meravigliosa stretta fisica, un abbraccio muto ed armonico di corpi ravvicinati, dormienti e consolati.
“Morire non impedisce a un padre di tornare a casa. Morire è un atto come un altro. Una scomparsa totale che gli avrebbe impedito di dormire, di parlare e di mangiare, questo non aveva senso nella mia mente. Devo aver immaginato, credo, che morire significasse in fondo vivere ancora, ma in un’altra famiglia, con un’altra donna e altri figli. Era facile quindi non morire: aprire gli occhi, tenerli spalancati camminare senza fermarsi sarebbe bastato a tenere lontana la morte“.
La bimba, a sei anni, semplifica e riduce la morte a qualcosa di temporaneo e permeabile. La madre, invece, preferisce eluderla optando per un esilio fatto di parole scritte (e non pronunciate). La realtà diviene così per la donna solo spunto fantastico per nutrire invenzioni poetiche e letterarie, un alibi assordante per coprire lo strazio di un’assenza.
Ci sono tanti vuoti in questo microcosmo, vuoti che la Ghata racconta perché, evidentemente, li ha conosciuti realmente. Il vuoto lasciato da un uomo che muore, il vuoto di una distanza tra una vedova e un’orfana, il vuoto di certi silenzi complicati e sacri come un tabu.
Recuperare gli oggetti che erano stati del padre lo riconduce accanto, una presenza invisibile e certa. Da chiamare con un semplice gesto, da spiare con l’eco delle sensazioni più intime ed ancestrali, quelle che legano indissolubilmente un padre a sua figlia.
Yasmine Ghata ha perso suo padre a sei anni. La bimba che parla è la Ghata che rivede in queste pagine se stessa, sua madre e la sua infanzia. “La bambina che imparò a non parlare” contiene una confessione d’amore filiale nei confronti di un padre e, nel contempo, la rivelazione di un debito importante, quello verso una madre scrittrice. “L’immaginazione è cosa contagiosa tra madre e figlia, è il nostro ossigeno, il nostro pane quotidiano, il nostro vestito per l’inverno e per l’estate“.
Scivola via docilmente questo libro. Non affatica e non preme. La scrittura della Ghata è intensa, piena e molto elegante. C’è tutto il buon gusto di chi sceglie con cura ogni termine perché sa che non è giusto sciupare, annacquare o, peggio, speculare sulle emozioni e sui sentimenti, buoni o dolorosi che siano.
Edizione esaminata e brevi note
Yasmine Ghata è nata in Francia nel 1975. E’ figlia di Jean Ghata e della poetessa di origini libanesi Vénus Khoury Ghata. Ha studiato storia ed arte presso la Sorbona e all’École du Louvre, specializzandosi in arte islamica. Il suo primo romanzo si intitola “La notte dei calligrafi” (“La Nuit des calligraphes”), è stato pubblicato nel 2004 per Fayard (nel 2005 per Feltrinelli in Italia) ed è ispirato alla figura di sua nonna, Rikkat Kunt. Nel 2009 arriva “Le târ de mon père”, inedito in Italia. Nel 2010, sempre per Fayard, la Ghata pubblica “La bambina che imparò a non parlare” (“Muettes”), edito in Italia da Del Vecchio.
Yasmine Ghata, “La bambina che imparò a non parlare”, Del Vecchio Editore, Cosenza, 2010. Traduzione di Angelo Molica Franco.





Follow Us