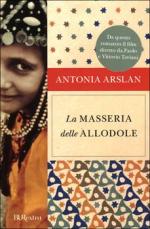
“La masseria delle allodole” è un romanzo tragico e commovente, intriso di nostalgia e di dolore eppure dolce come il ricordo della Patria Perduta – l’Armenia – che risplende in un cielo di sogno, luogo smarrito per sempre, spazzato via dalla crudeltà e dal fanatismo.
“La masseria delle allodole” è soprattutto un romanzo necessario non solo perché tratta letterariamente di un evento storico – il genocidio degli armeni nel 1915-16 ad opera dei turchi – che non ha mai avuto giustizia, ma perché l’esigenza del narrare traspare tra le pagine, come se l’Autrice non avesse più potuto tacere sulle vite incompiute dei suoi antenati e le loro storie, in parte vere in parte immaginate, si fossero con forza imposte, avessero preteso di concretizzarsi nella scrittura e di trovare così un destino. E occhi che le guardassero con la stessa umana compassione e compartecipazione dell’Autrice.
Così la piccola città dove un popolo vive serenamente si anima: il mite zio Sempad “dal semplice cuore”, la forte Shushanig, sua moglie, le giovani figlie Veron e Azniv-la bella e i bambini, i piccoli vivaci ragazzini che si somigliano a tutte le latitudini, ci diventano famigliari e partecipiamo ai loro preparativi per le feste pasquali e poi per l’arrivo di un parente lontano, lo zio Yerwant, che da quarant’anni vive in Italia.
Tutto – attese, speranza, sogni, beni –verrà spazzato via come in un uragano dal delirio della pulizia etnica, da un nazionalismo fanatico ed ottuso che progetta il massacro con efficienza e sistematicità.
“L’operazione deve essere condotta in modo molto moderno, con precisione chirurgica. Bisogna evitare di allarmare o coinvolgere, con spettacoli pietosi, i vicini di casa degli armeni, i loro amici turchi, i missionari americani, gli ebrei, i greci poi, che sono tanti. La partenza deve svolgersi con fredda regolarità, nessuno deve ricordarsi delle scomposte cacce all’uomo dei tempi del sultano, quando i cadaveri degli armeni morti venivano accatastati trionfalmente per le strade di Erzerum o di Costantinopoli”. (p.128)
La masseria delle allodole, la casa di campagna appena restaurata e resa elegante per far festa allo zio diventa il mattatoio nel quale, con rapidità sconvolgente, si svolge il massacro dei maschi del paese. Rimangono vecchie, donne, bambine e un “bambino-vestito-da-donna” che fortunosamente si salverà.
La loro sorte sarà peggiore: costretti a mettersi in viaggio, subiranno una spaventosa deportazione attraverso il deserto, decimati dalle fatiche, dalla fame, dalla sete, dalle malattie e dalle violenze della soldataglia, finiranno comunque sterminati senza pietà. Immane tragedia collettiva, cui l’Autrice dà le voci e il volto dei suoi parenti in gran parte mai conosciuti, solo evocati dai racconti del nonno Yerwant e forse visti in qualche sbiadita fotografia.
“Sempad e i suoi avranno sepoltura cristiana. A tutti gli altri armeni che perderanno la vita in quei mesi funesti, trucidati, torturati, morti di sete e di fame lungo le strade anatoliche, con scherno coerente sarà negato anche ogni funebre rito. O meglio: non ce ne sarà bisogno. Un singolo morto era prima un essere che respirava, era vivo, e la sua spoglia è un cadavere che può essere onorato: centomila morti sono un mucchio di carne in putrefazione, un cumulo di letame, più nulla del nulla, un’immonda realtà negativa di cui disfarsi”. (p.114)
Raccontando singole storie che s’intrecciano l’Autrice rende giustizia non solo alla sua famiglia, ma a tutta la stirpe armena, a quelli che altrimenti resterebbero un mucchio di carne in putrefazione, cadaveri anonimi, scarti della storia da liquidarsi in poche righe nei libri.
Ed invece quale dignità in certi loro gesti: nella vecchia Nevart che s’avvia, sola, nel deserto, a morire, figura tragica, ieratica, cui “sarà affidata la forza immensa di un intero popolo che muore e il pianto di Dio che l’accompagna” (p.151), o nel canto finale di Azniv, sfiorita, abbrutita dalle fatiche e dalla violenza, che si sacrifica per salvare il resto della famiglia.
Le ultime speranze di un popolo in estinzione sono affidate alle donne, ha qualcosa di sacro e terribile la loro carovana di poveri esseri cenciosi e sporchi, tenuti fuori dalle città come lebbrosi, senza possibilità di venir aiutate (c’è la pena di morte per chi soccorre o nasconde un armeno). Sono inguardabili, scomode, fastidiose come ogni sofferenza.
Vengono alla mente i versi di Primo Levi rivolti ad altre donne, le ebree: “Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d’inverno”.
Eppure queste donne sanno a tener viva la speranza, depositarie della continuazione della specie, riescono a salvare qualche bambina e Nubar, il maschietto-vestito-da-donna. Le loro vite incompiute lasciano una traccia e trovano un futuro in quei superstiti e da loro discenderà l’Autrice, colei che presta ascolto e voce alle creature scomparse, completandole con la sua immaginazione.
Nella devastazione generale la salvezza giunge per vie avventurose, in una frenetica lotta contro il tempo, tramite figure di poveri, di umili: Ismene, la lamentatrice greca, il pope ortodosso Isacco, il mendicante musulmano Nazim.
Sono loro a raggiungere la carovana, ad avvisare un fratello che fa il medico ad Aleppo e ad organizzare la strategia di fuga. Si sentono chiamati ad un compito importante, eroi per una volta, protagonisti di una storia “grande e terribile”, seppure poveri e di altra etnia. È il loro riscatto, pur nelle difficoltà trovano forza e ingegno e così tre bambini si salvano, un piccolo seme nella bufera generale. Niente e tutto, l’ultimo retaggio della freschezza e vivacità di un popolo “docilmente sciocco”, appagato del suo benessere e incredulo di fronte ai segnali di pericolo. I personaggi infatti dimenticano i presentimenti, non danno loro importanza finché il destino si compie e ogni felicità, ogni sicurezza e progetto vengono spazzati via.
Il romanzo non è solo vicenda dei deportati, l’autrice narra anche della nostalgia e del ricordo di chi ha lasciato, a soli tredici anni, quella patria. Il nonno Yerwant è partito per incompatibilità con la matrigna, ha studiato al Collegio Armeno Moorat di Venezia; diventato medico, vive a Padova ed ha sposato una donna italiana, che gli ha dato due figli.
Yerwant intesse una viva corrispondenza col fratello Sempad, farmacista, sempre rimasto in patria, e progetta un viaggio al paese natale quando scoppia la prima guerra mondiale, le frontiere si chiudono e le notizie giungono frammentarie e tragiche. Il romanzo narra così l’angoscia di chi vive altrove e si ritrova ad assistere impotente al dramma.
“Lui, l’uomo impaziente, il chirurgo fulmineo, deve reimparare l’attesa orientale, dipendere dalle notizie che arrivano, non potere niente, non fare niente. Non c’è altro che aspettare, e veder morire un po’alla volta il suo orgoglio. Se tornasse, sarebbe un paria, un maledetto come gli altri… ferito dalla vacua baldanza dei lodatori della guerra, in quell’estate mortale Yerwant assapora fino in fondo la sua intima diversità e smette di amarsi”. (p.187)
Yerwant è un uomo forte, imperioso, autoritario. I suoi figli non conoscono la sua lingua natale, non sentono le loro origini, modificheranno anche il cognome, sono italiani come la madre e lui preferisce che crescano così, il suo dono è l’appartenenza totale al loro paese senza nostalgia, senza ricordi, in una provincia tranquilla e sonnolenta.
Dopo l’eccidio Yerwant seppellirà dentro di sé dolore e nostalgia.
“Oppresso da un infinito senso di colpa – la colpa stessa di esistere come armeno, di sopravvvivere, di avere successo –Yerwant non scenderà mai più di sua volontà nelle radici della sua appartenenza, nei musicali, colorati ricordi del Paese perduto, mai più fino a quando li racconterà alla bambina come fiabe lontane, forse inaccessibili, forse sognate”. (p.139)
Da quei racconti nascerà il romanzo.
Articolo apparso su lankelot.eu nel settembre 2007
Edizione esaminata e brevi note
Antonia Arslan (Padova 1938), scrittrice e saggista italiana di origini armene. Laureata in archeologia, è stata professore di Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea all’Università di Padova. È autrice di saggi sulla narrativa popolare e d’appendice “Dame, droga e galline. Il romanzo popolare italiano fra ‘800 e ‘900”, Guerini 1998, e sulla “galassia sommersa” delle scrittrici italiane “Dame, galline e regine. La scrittura femminile italiana fra ‘800 e ‘900”, Guerini 1998.
Ha tradotto le raccolte “Il canto del pane” (Guerini 1992) e “Mari di grano” (Paoline 1995) del poeta armeno Daniel Varujan. Ha curato un libretto sul genocidio armeno “Metz Yeghèrn. Il genocidio degli Armeni”, di Claude Mutafian, e una raccolta di testimonianze di sopravvissuti rifugiatisi in Italia “Hushèr. La memoria. Voci italiane di sopravvissuti armeni (Guerini).
“La masseria delle allodole” è il suo primo romanzo.
Da questo libro è stato tratto il film omonimo dei fratelli Taviani.
Antonia Arslan, La masseria delle allodole, Milano, Rizzoli 2004.
Links:
Sul genocidio armeno:
http://it.wikipedia.org/wiki/Genocidio_armeno
http://freeweb.dnet.it/liberi/genoc_armeno/genoc_arm.htm
http://www.zadigweb.it/amis/ric.asp?id=4
sito ufficiale dell’autrice: http://www.antoniarslan.it/
altro: http://www.literary.it/rubriche/dati/intervista/bettiol/antonia_arslan.html





Follow Us